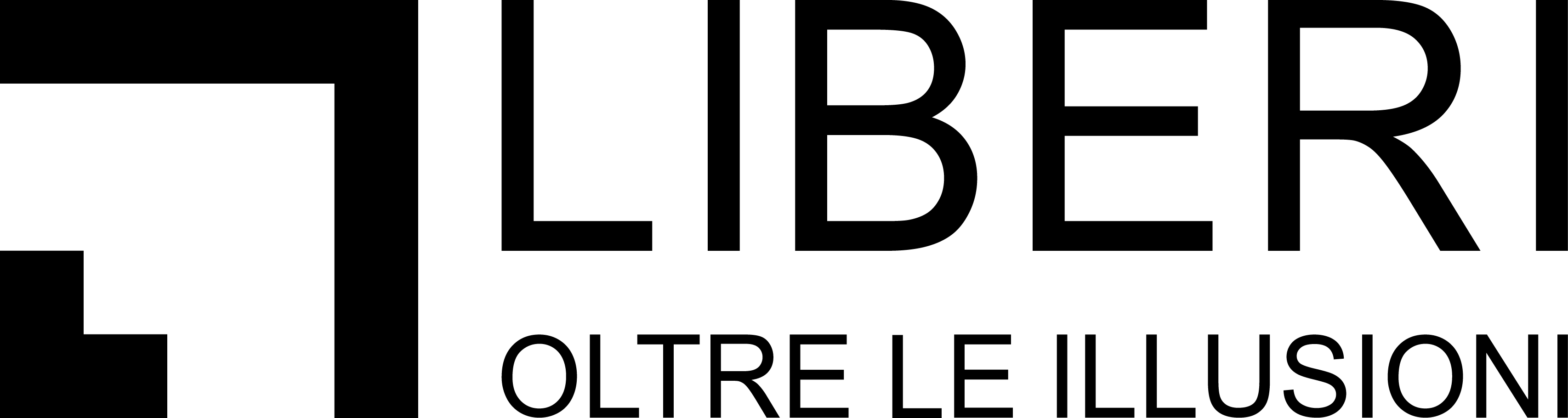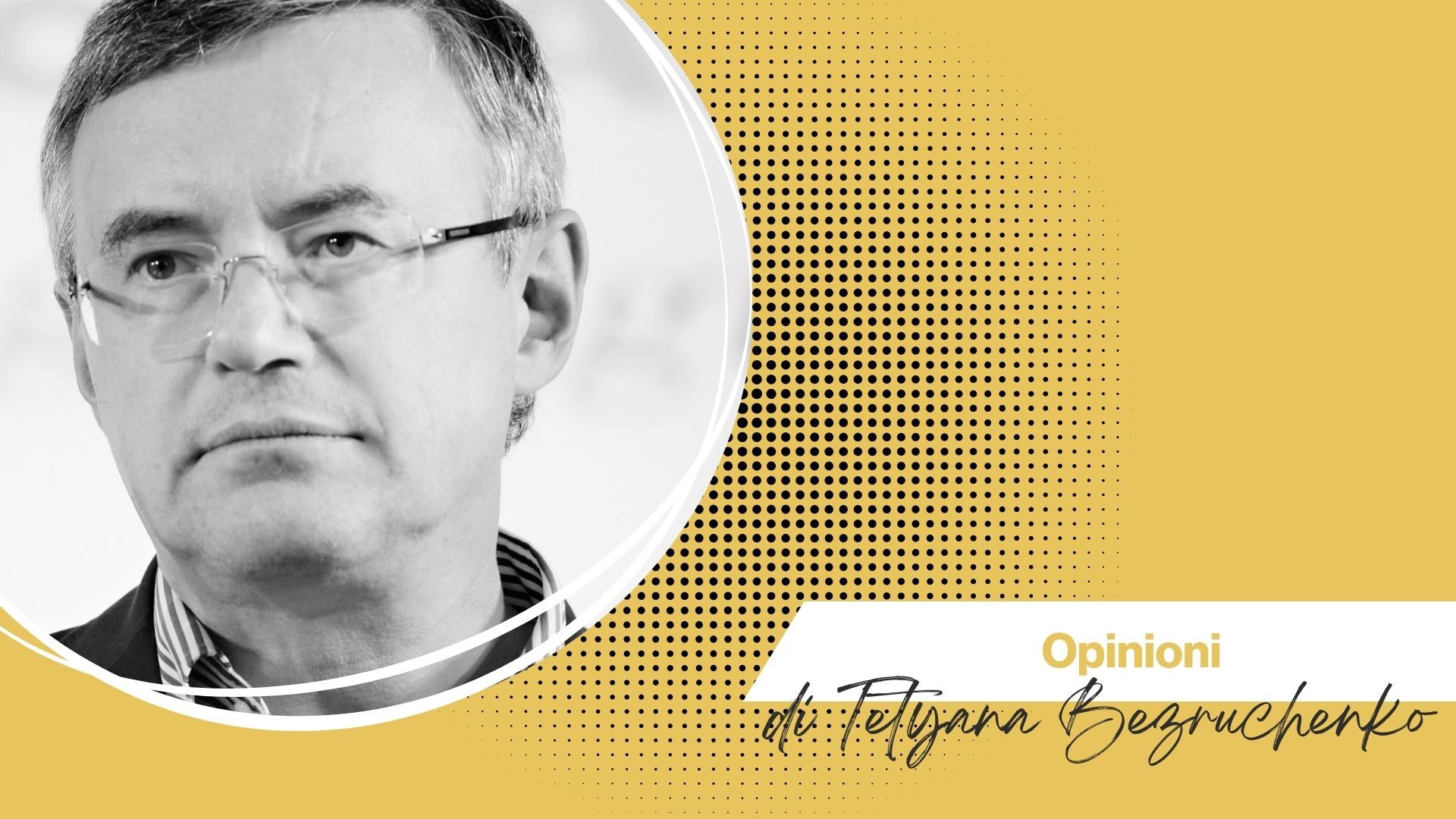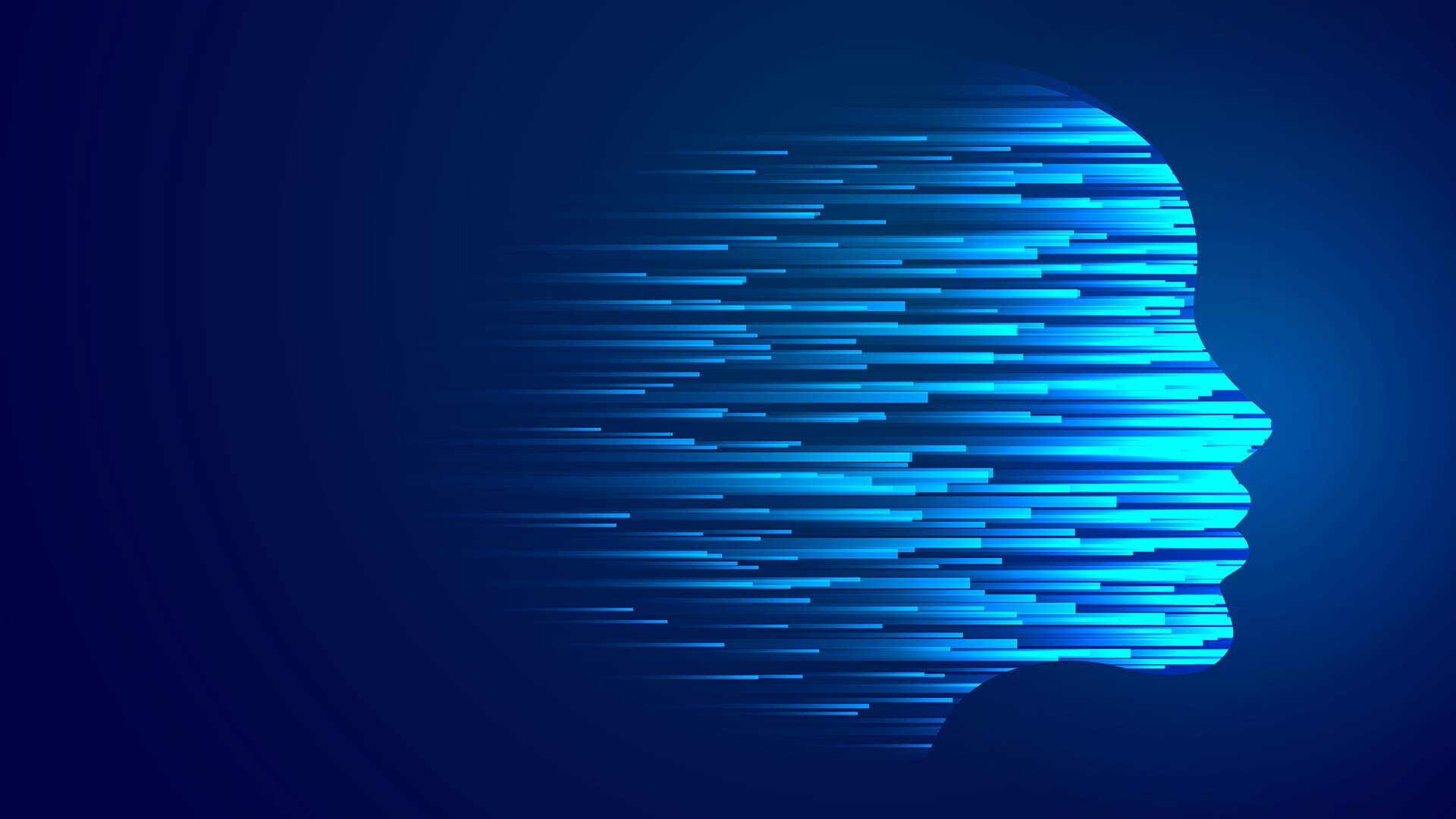Con Blurrr Joanne Robertson firma il suo disco più evanescente e al tempo stesso più carnale. È un album che sembra nascere dall’invisibile, dalle pause e dai vuoti tanto quanto dalle note, eppure quello che resta è un corpo sonoro che pulsa di vita, di intimità non mediata. Robertson è sempre stata un’artista schiva, laterale, ma qui sceglie la radicalità del silenzio come materia da scolpire, una forma di folk che implode nel sogno.
La voce, fragile e disarmata, non guida ma accompagna, come se fosse essa stessa un’eco del mondo interiore che racconta. Accanto a lei, il violoncello di Oliver Coates si innesta come un filo di luce che incrina l’ombra, aggiungendo tensione e spessore emotivo. Brani come Always Were o Gown non costruiscono narrazioni lineari: sono immagini sospese, piccoli dipinti sonori che si aprono e si richiudono come se fossero sguardi rubati.
Robertson si muove tra influenze che vanno dalla scuola del minimalismo folk inglese (pensiamo a Bridget St John o Vashti Bunyan) fino ai territori più astratti di un’Hope Sandoval, ma senza mai ridursi a citazione. È un mondo suo, che accetta la fragilità come punto di forza, che abita l’errore, l’incompiutezza, facendone poesia.
Blurrr è un titolo che dice molto, tutto sembra sfocato, indefinito, eppure l’emozione arriva diretta, nitida. Alla fine ti accorgi che quelle canzoni, così fragili e sfocate, hanno cambiato il silenzio intorno a te, come se avessero ridisegnato l’aria stessa che respiri.
Con Bleeds i Wednesday raggiungono una forma di maturità che non è addomesticata, ma al contrario più spietata, più concreta. Dopo il successo di Rat Saw God molti si aspettavano la ripetizione di una formula; invece la band prende la propria identità di “creek rockers” e la espone a una luce diversa, più cupa e più riflessiva. Qui il sangue del titolo non è solo metafora, ma materia reale di ferite, traumi, residui di relazioni finite, storie di piccole comunità che sopravvivono tra fede corrotta e provincia disillusa.
Il lavoro del produttore Alex Farrar amplifica questo realismo. In Reality TV Argument Bleeds la band affonda in un noise teso, mentre Townies diventa una ballata sporca, capace di un lirismo che non si concede mai al sentimentalismo. È questa l’essenza di Wednesday. Raccontare l’intimità senza levigarla, far sentire il peso della ruggine, dell’asfalto, dell’umidità delle case del Sud.
C’è un legame evidente con la tradizione “southern gothic”, non solo musicale ma letteraria: Faulkner, Flannery O’Connor, fino a certi echi di Drive-By Truckers. Ma la band non imita trasformando quell'eredità in qualcosa di urbano, attuale, che parla di social media, di precarietà, di comunità che si sfaldano. Persino l’assenza annunciata di MJ Lenderman dai tour aggiunge un senso di precarietà che risuona con il tema stesso del disco; la stabilità è sempre provvisoria, i legami sanguinano.
Con Sysivalo Mika Vainio ci lascia un’ultima stanza da attraversare, e quella stanza è fatta di ombre. Non c’è linearità né melodia, piuttosto una serie di corridoi, aperture e spiragli in cui la luce arriva come da sotto terra, intermittente, più eco che presenza. È un disco che non parla al cuore nel senso convenzionale, ma alle ossa, alle viscere. Ogni frequenza bassa, ogni rumore sospeso sembra vibrare dentro più che intorno.
Le tracce, brevi e appuntite, funzionano come etude, esercizi di sottrazione che vanno al nucleo stesso del suono. Un corno lontano, un ronzio elettrico, un drone interrotto. Basta pochissimo per aprire un varco. A tratti un requiem minerale, a tratti un paesaggio industriale ormai deserto. C’è qualcosa dei Coil più severi, un’eco della prima scuola elettronica tedesca, ma qui tutto è ridotto all’osso, depurato, più vicino al silenzio che al rumore.
L’esperienza è fisica, quasi ascetica, contornata dalla sensazione che quel bagliore nero, quella “luce di carbone”, continui a tremolare anche dopo che il disco è finito. È un testamento spoglio e potente, che non chiede approvazione ma presenza, attenzione, disponibilità a restare.
Ci vuole poco per farmi felice. Ma veramente tanto felice. Tutto il panorama alternative rock/post-punk va in una direzione. Questi ragazzacci di neanche 25 anni l’uno rappresentano a mio avviso il concetto di freschezza. Senza parlare di quel capolavoro e classico istantaneo Heavy Metal del frontman Cameron Winter, la compagine newyorkese espande lo stesso concettuale liricismo a sonorità aliene ma mai così nostalgiche. Il disco precedente lasciava intuire una band in bilico tra ironia e ricerca, Getting Killed è il momento in cui i Geese decidono di buttarsi nel caos senza freni. L’album sembra scritto con l’urgenza di un gruppo che non vuole più piacere a tutti i costi, ma divertirsi con il proprio stesso disordine. Dieci giorni in studio e quello che resta è un lavoro febbrile, pieno di colpi di testa, di canzoni che si piegano e si spezzano senza mai rassicurare davvero.
Ci sono momenti di puro delirio, in cui fiati e chitarre si inseguono fino a collidere, e altri in cui l’energia si ricompone in groove inaspettati, quasi soul, come se la band giocasse a sabotare le proprie canzoni dall’interno. È un rock che prende in prestito dal post-punk il nervosismo e l’urgenza, ma lo spinge verso territori più teatrali, più sghembi, con un gusto che ricorda a tratti i The Strokes, i migliori Arctic Monkeys, qualcosa di Pere Ubu, Talking Heads, Mark Smith e Iceage. Tutto questo con una sfrontatezza che appartiene solo a loro.
Il cuore dell’album, però, non sta nei singoli brani ma nell’insieme. Un viaggio schizofrenico, a metà tra festa e collasso, dove il frontman sembra muoversi come un attore in scena, alternando confessione e urlo, sarcasmo e disperazione. Nel finale, la title track abbandona l’ironia e lascia intravedere la paura vera, come se sotto tutta quella spavalderia ci fosse un nervo scoperto.
Getting Killed è vitale, sanguigno, pieno di rischi. Geese sembrano dire che oggi fare rock non significa trovare la formula giusta, ma avere il coraggio di farsi a pezzi davanti a chi ascolta.
Jeff Tweedy è uno di quei musicisti che non hanno più nulla da dimostrare, e forse proprio per questo continuano a sorprendere. Twilight Override non rincorre l’effetto speciale, piuttosto una sorta di almanacco, preferendo stare un passo di lato, abitare quella zona incerta. È lì che la sua voce si muove, come un filo che tiene insieme i ricordi e le assenze.
L’album sceglie la semplicità come lingua madre. Voce e chitarra sono al centro, ma tutto attorno compaiono dettagli che spostano continuamente la percezione: un arpeggio elettrico, un riverbero che si spegne troppo presto, un’armonia che sembra quasi sbagliata e invece apre un’altra porta. Long Goodbye si adagia su un folk sospeso, Humming Wire ha il calore domestico delle cose usurate, mentre The Last Blue Light dissolve la forma.
Non mancano i fantasmi di Wilco, ma arrivano filtrati, come ombre passate attraverso un vetro opaco. Tweedy non costruisce un best of mascherato, piuttosto distilla la sua storia in gesti minimi, quasi frugali. È un disco fatto di frammenti che non pretendono di diventare monumento, ma che, messi insieme, formano un paesaggio intimo e vulnerabile.

One Battle After Another (Original Motion Picture Soundtrack)
di Jonny Greenwood Genere
Uscita: 26/09/2025 |
Genere: Soundtrack
Greenwood torna alla colonna sonora con un lavoro che sembra più un campo di battaglia interiore che un semplice accompagnamento filmico. Un susseguirsi di tensioni, di equilibri instabili, di stratificazioni che sembrano riflettere tanto la trama del film quanto un discorso personale sul tempo presente.
L’orchestra qui non è mai classica in senso puro. Gli archi si muovono come lame, i fiati oscillano tra marcia e lamento, le percussioni assumono spesso il ruolo di detonatori. Ma accanto a questa densità emergono passaggi quasi sospesi, come piccole tregue. Greenwood sa benissimo che l’impatto emotivo arriva non solo dalla violenza sonora, ma dal vuoto che la precede.
A tratti il lavoro richiama There Will Be Blood per l’uso della dissonanza, altrove sembra guardare all’eleganza di Phantom Thread; ma stavolta il tono è più diretto, più urgente, meno interessato a creare un’estetica che a scuotere.
Una composizione che alterna momenti di free jazz alla Sun Ra Arkestra a epifanie come i primi 3 minuti della pellicola che valgono da soli il biglietto.
Cate Le Bon ha sempre costruito dischi come sculture, con un senso della forma che sembra più vicino all’arte visiva che alla musica. Con Michelangelo Dying questa idea diventa manifesto: un album che riflette sull’atto stesso di modellare, di scolpire, di portare la materia al punto di rottura.
Qui la sua scrittura si fa ancora più stratificata. Chitarre nervose, sintetizzatori obliqui, linee vocali quasi sul gotico. Ogni brano un blocco da sbozzare. In Carrara le melodie si ripiegano su se stesse, in Dust and Marble la voce si dissolve in un contesto che ricorda le derive più astratte dei Talking Heads o di Laurie Anderson, mentre The Chisel Remembers si muove su ritmi spezzati che hanno il sapore di un kraut-rock deformato. Alle percussioni, che ve lo dico a fare, c’è Valentina Magaletti.
Il titolo è programmatico. Non la gloria del Michelangelo compiuto, ma la fragilità di quello che muore, di quello che non finisce. È un disco che abita l’incompiutezza, che celebra il gesto più del risultato, e che nella sua tensione apre un varco raro nella scena art-rock/avant-pop contemporanea.
Se Pompeii era una casa piena di stanze storte e colori innaturali, Michelangelo Dying è un atelier in rovina, in cui i frammenti diventano più eloquenti delle opere finite. Cate Le Bon conferma così di essere una delle pochissime voci capaci di rendere la forma canzone non solo raffinata ma necessaria, un linguaggio per affrontare le crepe del presente.