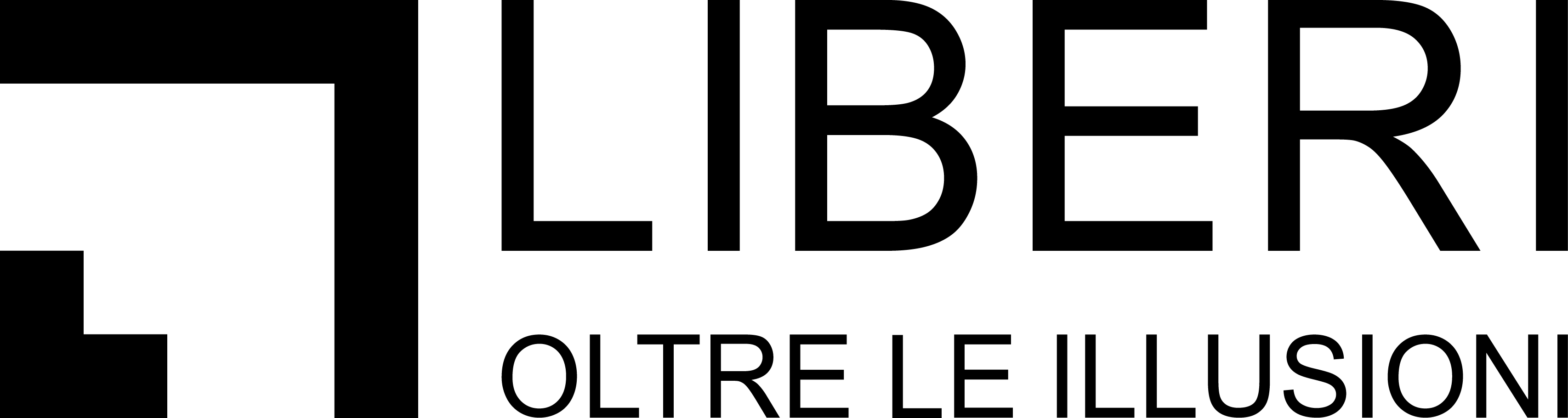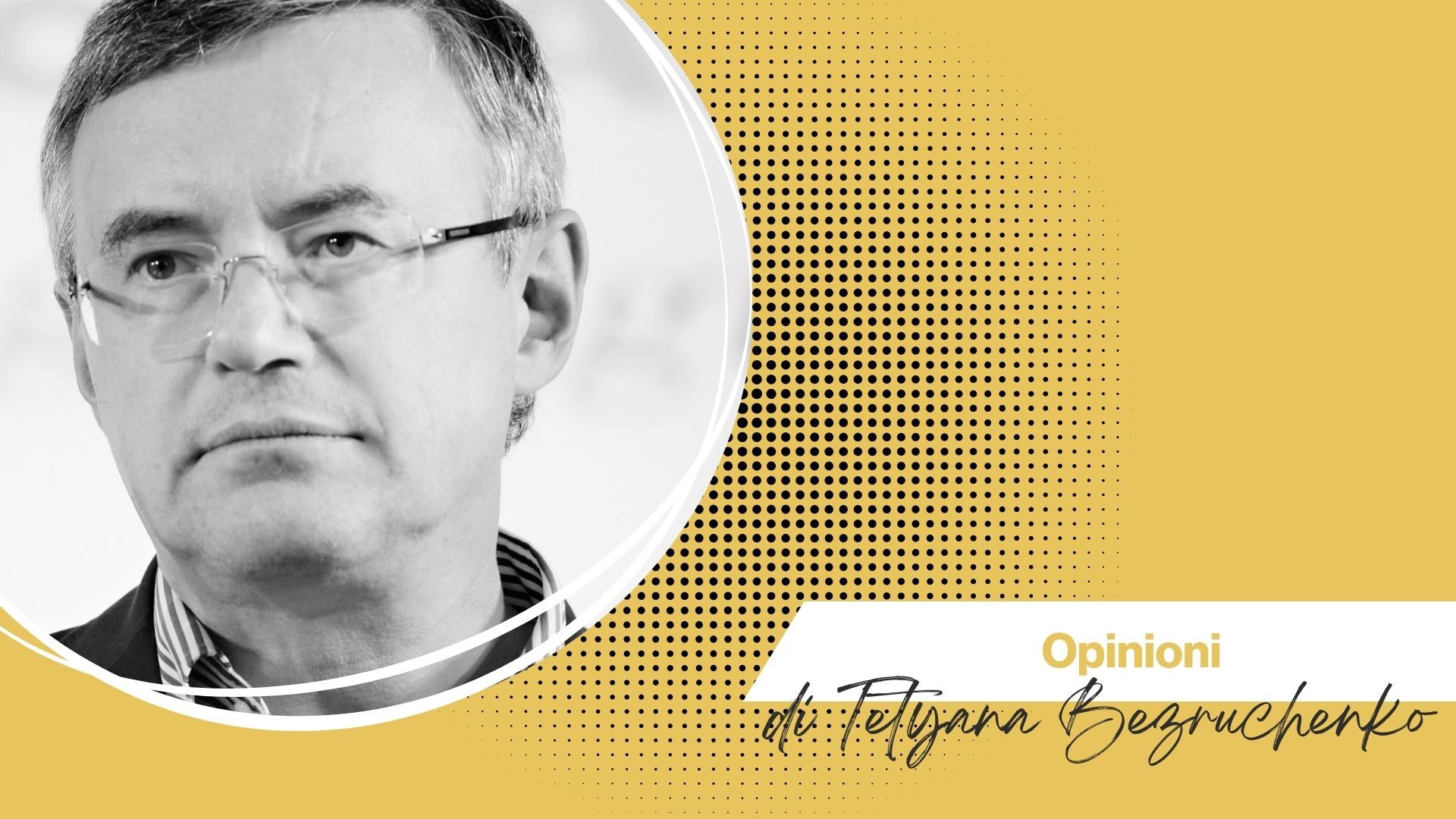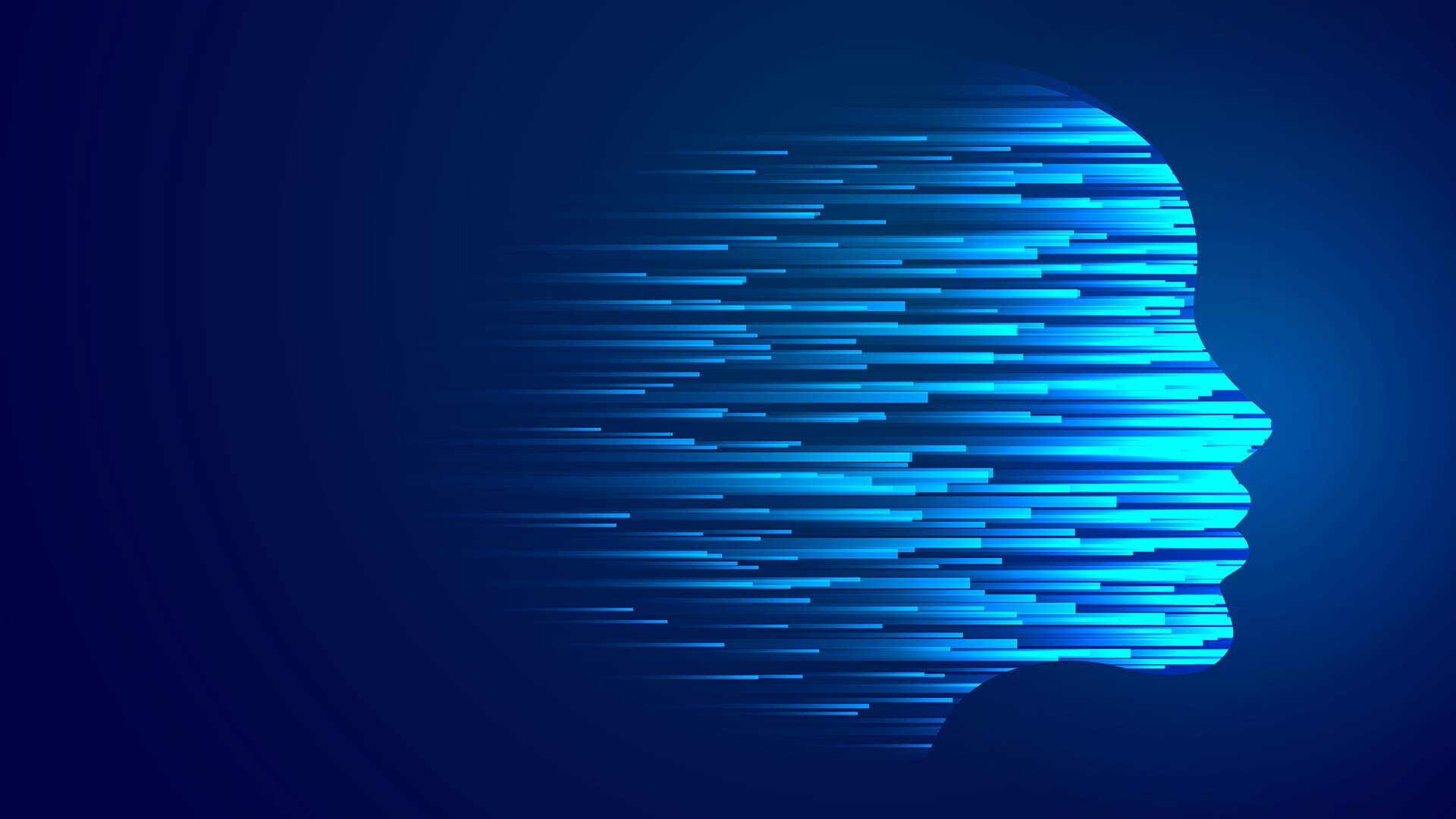1. L'obiettivo dei paesi arabi nel 1948 era la distruzione di Israele
La prima guerra arabo-israeliana scoppiò il 15 maggio del 1948, il giorno dopo la proclamazione dello Stato di Israele e la fine del mandato britannico su Palestina e Transgiordania, così come disposto dal piano di spartizione delle Nazioni Unite adottato il 29 novembre del 1947 con la famosa risoluzione n. 181.
Il neonato Stato ebraico fu invaso dagli eserciti regolari di cinque Stati arabi: Egitto, Transgiordania, Iraq, Siria e Libano. La prima ondata della storiografia israeliana, così come una parte significativa della politica e dell'opinione pubblica mondiale di allora e di oggi, ha sostenuto che l'attacco arabo fosse un'azione coordinata avente come obiettivo quello di distruggere Israele.
La tradizionale narrazione sionista della Guerra di Indipendenza presentava Israele come un “Davide” indifeso di fronte a un “Golia” implacabilmente ostile alla strenua ricerca di perseguire il suo annientamento. La metafora biblica veicola due ulteriori concetti: da una parte la sproporzione di forza fra la piccola Israele e la titanica unione dei paesi arabi, e dall’altra la caratura dell’atto eroico di resistenza del più debole. Non stupisce la forza con cui questi miti si sono sedimentati, perché proprio attorno ad essi è stata costruita parte della memoria collettiva delle generazioni del 1948. Il tradizionale resoconto sionista della guerra del 1948 non è dunque «storia nel vero senso della parola, (…) [ma] un esempio da manuale dell'uso di una versione nazionalista della storia nel processo di nation-building» – come afferma Avi Shlaim.
Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, un gruppo di “nuovi storici” israeliani ha iniziato a mettere in discussione i miti fondativi di Israele, confermando in parte quello che già la storiografica araba e palestinese aveva scritto (es: Walid Khalidi). Questa revisione storiografica fu possibile essenzialmente grazie a due fattori: la possibilità di accedere per la prima volta a documenti degli archivi governativi israeliani e britannici, desecretati dopo trent'anni (Archives Law 5715-1955, Israele – Public Records Act 1967, c. 44 – Regno Unito) e il nuovo clima politico che si era creato in Israele dopo la Guerra in Libano del 1982 e la Prima Intifada del 1987. Studiosi come Ilan Pappé, Avi Shlaim, Benny Morris e Simha Flapan, hanno iniziato a decostruire la narrazione tradizionale sionista partendo proprio dal 1948.
I nuovi storici hanno rivelato che gli eserciti arabi erano sostanzialmente impreparati e militarmente deboli. I capi di stato maggiore arabi, riuniti ad Amman il 30 aprile 1948, stimavano che sarebbero stati necessari anni e ingenti risorse per preparare una forza adeguata a conquistare la Palestina, suggerendo il rinvio dell'invasione. Gli Stati arabi erano diffidenti l’uno dell’altro, scarsamente coordinati tra loro e con eserciti sostanzialmente privi di esperienza bellica. Israele, al contrario, aveva un apparato militare più organizzato, dotato di un comando centralizzato e in grado di operare più rapidamente.
Ma se l'obiettivo dei paesi arabi non era la distruzione dello Stato ebraico, perché attaccarlo?
La decisione di procedere con l'azione armata fu l'esito di complesse motivazioni:
- Distrarre l'opinione pubblica interna, che si dimostrava delusa e scontenta. La Palestina fu usata come fumo negli occhi delle popolazioni locali, sempre più critiche nei confronti dei rispettivi governi nazionali.
- Mantenere gli equilibri regionali e ottenere vantaggi territoriali. Ciascun paese arabo temeva che gli altri potessero ottenere una parte della Palestina, alterando gli equilibri regionali. In particolare, fu la paura di una grande Transgiordania che spinse l'Egitto, la Siria e l'Arabia Saudita a intervenire, anche se impreparati e con un dispiegamento non ottimale delle proprie forze. Il caso della Transgiordania ha fatto scuola: le intenzioni di re Abdullah, che ambiva a impossessarsi di larghi possedimenti nel nord della Palestina, rivelano che il sovrano avesse nell’evitare la nascita di uno Stato palestinese indipendente, un interesse comune a quello della leadership sionista.
E gli altri paesi?
L'intervento iracheno fu motivato dalla volontà di porsi alla guida della lotta araba sulla questione palestinese; la Siria temeva la pressione irachena e i piani hashimiti di dominio della Mezzaluna Fertile; la decisione egiziana di intervenire fu presa invece all'ultimo momento, anche per contenere le ambizioni del re Abdullah.
«Certamente, tutti i leader arabi desideravano sconfiggere i sionisti e preservare la Palestina per gli arabi – tutti fecero dichiarazioni bellicose e si comportarono come se fosse in loro potere sconfiggere gli ebrei – ma non avevano né i piani di battaglia né la capacità di farlo. Fin dall'inizio, la lotta riguardava l'equilibrio di potere nella regione e il futuro del mondo arabo; non era una guerra intesa a distruggere lo Stato ebraico.».
Joshua Landis. Syria and the Palestine War: fighting King Abdullah’s “Greater Syria Plan”


2. La Nakba fu una conseguenza della guerra con i paesi arabi
La narrazione tradizionale ha spesso presentato l'esodo dei palestinesi come una conseguenza diretta della guerra del 1948, attribuendo così la responsabilità della nascita del problema dei profughi palestinesi alle leadership arabe.
Tuttavia, l’esodo, iniziato nel dicembre del 1947, «nel maggio del 1948 si era in gran parte già verificato» – ricorda Arturo Marzano. La svolta nell’espulsione della popolazione palestinese avvenne agli inizi del 1948, quando le forze ebraiche – in particolare l’Haganah – dopo aver ricevuto significative forniture di armi, mutarono la propria strategia militare in chiave più offensiva (vedi Piano Dalet). Questa svolta militare viene solitamente indicata come l’evento spartiacque tra “prima” e “seconda” ondata di profughi.
Sebbene sugli obiettivi del piano ci sia un dibattito aperto (Benny Morris sostiene non si possa parlare di un «sistematica politica di espulsione», al contrario di Ilan Pappé), non c’è alcun dubbio che l’esodo fosse iniziato prima del maggio del 1948 e che già migliaia di palestinesi fossero divenuti profughi, scacciati con la forza o spinti alla fuga dalle minacce e dai massacri perpetrati dall’Irgun, dal Lehi e dall’Haganah.
Tra il novembre 1947 e la fine della guerra nel 1949, i profughi palestinesi raggiunsero le centinaia di migliaia. Le stime variano, ma si attestano ad un numero superiore ai 700.000, pari a più della metà della popolazione araba residente in Palestina prima della guerra. Molti finirono in Libano (97.000), Siria (75.000), Striscia di Gaza (200.000) e Cisgiordania (280.000). La quasi totalità della classe media araba palestinese fu spazzata via. Furono distrutti o spopolati tra i 418 e i 532 villaggi palestinesi.
3. Nel 1967 furono gli arabi a volere la guerra
La Guerra dei Sei Giorni del 1967 è stata presentata da Israele come un'azione preventiva necessaria per difendersi da un imminente attacco dei paesi arabi, il cui obiettivo sarebbe stato la distruzione dello Stato ebraico. La storiografia più recente rivela una realtà ben diversa: gli Stati arabi non avevano l'obiettivo di distruggere Israele nel 1967. Al contrario, fu Israele ad iniziare la guerra.
Egitto, Siria e Giordania non avevano alcuna reale intenzione di intraprendere un'offensiva militare contro Israele. I paesi arabi erano militarmente impreparati e i loro eserciti erano molto più deboli di quello israeliano. Il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser, pur adottando una retorica aggressiva e bellicosa (che includeva proclami minacciosi di «spazzare via Israele»), non voleva effettivamente la guerra.
Le sue azioni, come lo spostamento di truppe nel Sinai e la chiusura degli stretti di Tiran al traffico marittimo israeliano, erano essenzialmente provocatorie e non rappresentavano una concreta minaccia per Israele. Agendo in questo modo, Nasser sperava di aumentare la propria autorevolezza a livello regionale. Voleva riaffermare la sua leadership e guadagnare simpatia nel mondo arabo, presentandosi come il salvatore della Siria contro le presunte minacce israeliane. Di fatto, era consapevole della debolezza militare dell'Egitto e non era realmente intenzionato ad attaccare Israele.
La leadership politica e militare israeliana era perfettamente consapevole del fatto che Nasser stesse bluffando. Il generale Yitzhak Rabin, capo di Stato maggiore all'epoca della guerra e poi primo ministro israeliano, dichiarò poco dopo in un'intervista: «Non credo che Nasser volesse la guerra. Le due divisioni che aveva inviato nel Sinai il 14 maggio non sarebbero state sufficienti per scatenare un'offensiva contro Israele. Lo sapeva lui, e lo sapevamo anche noi.» Anche Menachem Begin, chiamato a far parte del governo di unità nazionale poco prima della guerra, in un'intervista del 1982 ammise: «Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non furono le concentrazioni dell'esercito egiziano nel Sinai a implicare un imminente attacco di Nasser. Fummo noi a decidere di attaccarlo.»
Ufficiali come Ezer Weizman e Haim Bar Lev, che servirono nello Stato Maggiore, confermarono in seguito questa versione, e anche i servizi segreti israeliani e l’IDF sapevano che l'Egitto non avrebbe attaccato. Nonostante questa consapevolezza, Israele decise di muoversi per prima, presentando alla comunità internazionale la propria azione come autodifensiva, pur essendo ben consapevole di non star correndo alcun rischio concreto, vista l’impreparazione, la debolezza e la disorganizzazione militare araba.
In effetti, la Guerra dei Sei Giorni si concluse con una vittoria schiacciante dello Stato ebraico. In poche ore, l'aviazione israeliana distrusse quasi tutta quella egiziana, consentendo un'offensiva di terra rapida che portò alla ritirata di Nasser in 36 ore. Furono conquistate la Striscia di Gaza, la penisola del Sinai, la Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) e le Alture del Golan.
Nasser stava bluffando, e Israele ne approfittò.

4. L'obiettivo dei paesi arabi nel 1973 era la distruzione di Israele
Il 6 ottobre 1973 Egitto e Siria lanciarono un attacco a sorpresa non per annientare Israele, ma per rompere lo stallo post-1967 e provocare l’intervento delle grandi potenze, soprattutto degli Stati Uniti. L’obiettivo era una guerra limitata per riavviare il processo di pace e recuperare i territori persi; Sadat mirava soprattutto a una vittoria politica che restituisse prestigio all’Egitto e che gli consentisse di negoziare da una posizione di forza.
Il 16 ottobre 1973, il presidente Sadat davanti all'Assemblea del Popolo egiziano dichiarò: «Abbiamo dichiarato guerra solo dopo che tutte le grandi potenze, tutte le potenze, ci hanno chiuso le porte della pace in faccia. Abbiamo dichiarato guerra solo quando il mondo intero ha fatto orecchie da mercante alle nostre richieste di pace [...] Abbiamo dichiarato guerra per liberare la terra e ottenere il riconoscimento dei diritti dei palestinesi, al fine di raggiungere la pace».
Per comprendere come si sia arrivati alla guerra dello Yom Kippur è inevitabile considerare le guerre precedenti. Poiché i conflitti del 1948 e del 1967 sono già stati esaminati, ci concentreremo per un momento sulla crisi di Suez. Nel 1956 la campagna di Suez fu un attacco coordinato da parte di Israele, Francia e Gran Bretagna contro l'Egitto. Israele invase per primo la penisola del Sinai, fornendo un pretesto per l'intervento anglo-francese. Pertanto, definire il 1973 come l’ennesimo attacco da parte degli Stati arabi mosso dalla volontà di annientamento è inesatto, poiché Israele iniziò le ostilità nell’area sia nel 1956 che nel 1967.
L'attacco del 1973 fu una sorpresa totale per Israele. La comunità dei servizi segreti israeliani e la leadership politica si erano convinte che gli arabi fossero incapaci di lanciare una guerra. Questa valutazione, denominata “il concetto” (kontzeptia), portò a un catastrofico fallimento dell'intelligence. Nei primi giorni di guerra, Israele subì pesanti perdite e gravi battute d'arresto militari. Le forze egiziane attraversarono con successo il Canale di Suez e violarono la linea Bar-Lev, mentre i carri armati siriani furono ad un passo dallo sfondare le alture del Golan. Il comando israeliano era scioccato e disorientato.
Nonostante il disastro iniziale, Israele riuscì in una notevole ripresa militare grazie ai massicci rifornimenti militari giunti tramite l’Operazione Nickel Grass, che iniziò dopo alcuni ritardi iniziali. L’IDF respinse la prima avanzata siriana per poi avanzare nel territorio siriano, arrivando a portata di artiglieria di Damasco. Sul fronte meridionale, le forze israeliane, guidate dal generale Ariel Sharon, attraversarono il Canale di Suez, aggirarono le linee egiziane e circondarono la Terza Armata egiziana. Quando entrò in vigore il cessate il fuoco negoziato dall'ONU, l'IDF era già in marcia verso Il Cairo e Damasco, dopo aver ottenuto una vittoria militare decisiva.
Sebbene si trattasse di un trionfo militare, la realtà dipinge il risultato come una vittoria condizionata che ha profondamente scosso la società israeliana. L'alto numero di vittime (quasi 2.700 morti israeliani), gli iniziali fallimenti e la distruzione del mito dell'invincibilità israeliana hanno creato un trauma nazionale. Ciò ha portato a proteste pubbliche diffuse e alla caduta del governo di Golda Meir. Al contrario, gli arabi, in particolare l'Egitto, consideravano i loro successi iniziali come una grande vittoria psicologica che ripristinò l'onore e l'orgoglio nazionale, nonostante la sconfitta militare. Questa ritrovata fiducia è vista come un fattore cruciale che permise a Sadat di perseguire in seguito un trattato di pace con Israele.
In sintesi, l'affermazione è errata sotto alcuni aspetti fondamentali. La guerra del 1973 non fu semplicemente un atto di aggressione inteso a distruggere Israele, ma una guerra calcolata e limitata volta a rompere una situazione di stallo politico. Inoltre, lo scoppiare delle ostilità nel 1973 deve essere collocato nella ben più lunga storia militare della regione: Israele avviò gli scontri sia nel 1956 che nel 1967. Sebbene Israele abbia alla fine ottenuto una vittoria militare, questa è arrivata solo dopo un attacco a sorpresa, sconfitte iniziali e un pesante tributo in termini di vite umane, il che ha causato un trauma nazionale piuttosto che un trionfo incondizionato.

5. Il fallimento degli accordi di Oslo è da imputare solo alla leadership palestinese e all'opposizione di Hamas
Attribuire il fallimento di Oslo solo alla “mancanza di volontà palestinese” e all’opposizione di Hamas è riduttivo: pesarono difetti intrinseci degli accordi, azioni israeliane che li minarono, un forte squilibrio di potere e l’operato di gruppi estremisti israeliani. In questa lettura più ampia, i fattori di parte palestinese incidono, ma agiscono all'interno di un’architettura negoziale fragile e asimmetrica che ne ha condizionato l’esito fin dall’inizio.
Per prima cosa è bene ricordare che l’OLP arrivò ai negoziati indebolita dal crollo dell’URSS, dalla crisi finanziaria seguita al sostegno a Saddam Hussein nella Guerra del Golfo e dal declino d’influenza dopo l’evacuazione dal Libano nel 1982. Da questa posizione di debolezza l’organizzazione guidata da Arafat adottò un pragmatismo di necessità: accettò il principio dei due Stati e rinviò le questioni di Gerusalemme, dei rifugiati e degli insediamenti alla fase finale, legando la loro trattazione a condizioni di sicurezza in larga parte definite da Israele. La scelta fu una concessione strategica: comprare tempo e legittimità internazionale in cambio di un rinvio sui nodi più sensibili.
Hamas e Jihad islamica guidarono l’opposizione ad Oslo con una campagna di attentati suicidi avviata nel 1994 che provocò centinaia di vittime civili, alimentò la percezione d’insicurezza e logorò il consenso israeliano al processo di pace. Nella loro visione, gli accordi tradivano la causa palestinese e violavano l’idea di Palestina come waqf indivisibile; la violenza mirava esplicitamente a far deragliare il negoziato. Questo offrì ai governi israeliani ulteriori argomenti per sospendere i colloqui e rallentare l’attuazione degli impegni.
La leadership palestinese, intanto, restava frammentata: oltre agli islamisti, anche PFLP e DFLP contestavano Oslo da sinistra; la nuova Autorità Palestinese soffriva di corruzione, pratiche autoritarie e inefficienze amministrative, generando così disillusione interna. Lo stile di Arafat, incentrato su lealtà personali e competizioni tra apparati, accrebbe le rivalità, riducendo la capacità di governo e di implementazione sul terreno.
Bisogna poi avere ben presente che i negoziati non avvennero tra paria. L’impianto fu quello di un’autonomia senza piena sovranità, con i militari israeliani a dettare i termini operativi secondo priorità di sicurezza. Questa cornice era in netta continuità con la logica del piano di “autonomia” di Begin (1978): concedere diritti alle persone più che al territorio, mantenendo leve cruciali di controllo e rinviando rifugiati e Gerusalemme. Ne derivò un processo in cui la parte più forte - Israele - poteva gestire i tempi e le modalità con cui gli accordi venivano definiti, mentre la parte debole - OLP - si trovava nella condizione di dover concedere, a causa anche di una sempre crescente divisione interna.
Sul piano degli impegni, Israele violò l’essenza degli accordi continuando a creare “fatti compiuti” sul piano militare su cui non era disposto a retrocedere. Pur con il divieto di mutare lo status dei Territori prima del finale, tra 1992 e 1996 la popolazione dei coloni crebbe sensibilmente (circa +48% in Cisgiordania e +62% a Gaza), con nuovi ampliamenti e consolidamenti. L’effetto pratico fu di erodere la contiguità territoriale necessaria a uno Stato palestinese e di spostare, a ogni fase, l’asticella negoziale un poco più in alto.
Il ritiro fu limitato e l’occupazione non cessò. La Cisgiordania venne suddivisa in tre aree: A, B e C. Nelle prime due si trasferirono competenze civili all’autorità palestinese (e parte della sicurezza in B), ma l’Area C - dove ricadevano insediamenti, risorse e la maggioranza del territorio - rimase sotto il pieno controllo israeliano. Una rete di strade di bypass e gallerie collegò gli insediamenti senza attraversare centri palestinesi, spezzettando lo spazio palestinese in enclave. A Gaza, chiusure ripetute dei valichi e restrizioni ai movimenti trasformarono il territorio in una sorta di “prigione a cielo aperto”.
Anche gli estremisti israeliani cercarono di bloccare il processo. L’assassinio di Yitzhak Rabin nel novembre 1995 da parte di un nazionalista religioso coronò una stagione di incitamento all’odio della destra e del movimento dei coloni, che vedevano in Oslo un tradimento. L’omicidio tolse di mezzo il principale architetto politico della “gradualità” - i.e. il progressivo e controllato riconoscimento della parte palestinese - indebolendo la coalizione pro-accordi.
Persino i leader israeliani più moderati non puntavano a una piena sovranità palestinese. La loro visione privilegiava formule di confederazione con la Giordania e la permanenza sotto controllo israeliano di ampie porzioni della Cisgiordania, specie nelle zone attigue a Gerusalemme. In questa cornice, l’offerta di Ehud Barak a Camp David (2000), pur presentata come “generosa”, fu percepita dai palestinesi come insufficiente rispetto ai requisiti minimi per uno Stato contiguo e con sovranità reale sulla capitale e sui confini.
In conclusione, il fallimento di Oslo fu multicausale. Il terrorismo di Hamas e di altri gruppi pesò nel deteriorare il clima e nel corrodere il sostegno israeliano alla pace; ma operò all'interno di un processo strutturalmente difettoso e sbilanciato, segnato dall’espansione continuata degli insediamenti e dalla riluttanza delle leadership israeliane ad accettare una piena sovranità palestinese. L’esito non fu il collasso di un accordo “equilibrato” per sola intransigenza palestinese, bensì la somma di violenza, asimmetria negoziale e politiche di fatto che resero impraticabile una soluzione a due Stati realmente vitale.

Libri
- The Cold War in the Middle East: Regional Conflict and the Superpowers 1967-73. United Kingdom: Taylor & Francis, 2007.
- The Cold War and the Middle East. United Kingdom: Clarendon Press, 1997.
- Gelvin, James. Il conflitto israelo-palestinese: cent'anni di guerra. Torino: Einaudi, 2007.
- Herzog, Chaim. The War of Atonement: The Inside Story of the Yom Kippur War. United States: Pen & Sword Books, 2018.
- Khalidi, Rashid. Brokers of Deceit: How the U.S. Has Undermined Peace in the Middle East. United States: Beacon Press, 2013.
- Kimmerling, Baruch. Politicide: Ariel Sharon’s War Against the Palestinians. United Kingdom: Verso, 2020.
- Marzano, Arturo. Questa terra è nostra da sempre: Israele e Palestina. Roma-Bari: Laterza, 2024.
- Migdal, Joel S.. Shifting Sands: The United States in the Middle East. United States: Columbia University Press, 2014.
- Morris, Benny. The birth of the Palestinian refugee problem revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Morris, Benny. Righteous victims: A history of the Zionist-Arab conflict, 1881-2001. New York: Vintage, 2001.
- Pappé, Ilan. Storia della Palestina moderna. Torino: Einaudi, 2014.
- Pappé, Ilan. The Modern Middle East. United Kingdom: Routledge, 2005.
- Quigley, John. The Six-Day War and Israeli self-defense: Questioning the Legal Basis for Preventive War. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Rabinovich, Abraham. The Yom Kippur War: The Epic Encounter That Transformed the Middle East. United Kingdom: Knopf Doubleday Publishing Group, 2007.
- Smith, Charles D.. Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents. United States: Bedford/St. Martin's, 2020.
Articoli
- Barak, O. (2005). The Failure of the Israeli–Palestinian Peace Process, 1993–2000. Journal of Peace Research, 42(6), 719-736. (Original work published 2005)
- Eppel, Michael. “The Arab States and the 1948 War in Palestine: The Socio-Political Struggles, the Compelling Nationalist Discourse and the Regional Context of Involvement.” Middle Eastern Studies 48, no. 1 (2012): pp. 1–31.
- Khalidi, Walid. “Selected documents on the 1948 Palestine war.” Journal of Palestine Studies 27, no. 3 (1998): 60–105.
- Khalidi, Walid. “Why did the Palestinians leave, revisited.” Journal of Palestine Studies 34, no. 2 (2005): 42–54.
- Landis, Joshua. “Syria and the Palestine War: fighting King Abdullah’s Greater Syria Plan” in The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, ed. by Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, 176–203. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Morris, Benny. “Revisiting the Palestinian exodus of 1948” in The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, ed. by Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, 37–59. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Rogan, Eugene L. “Jordan and 1948: The Persistence of an Official History.” in The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, ed. by Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, 104–24. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Shlaim, Avi. “Israel and the Arab coalition in 1948” in The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, ed. by Eugene L. Rogan and Avi Shlaim, 79–103. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Shlaim, Avi. “The debate about 1948.” International Journal of Middle East Studies 27, no. 3 (1995): 287–304.
- Shlaim, Avi. “The Oslo Accord.” Journal of Palestine Studies 23, no. 3 (1994): 24–40.
Fonti primarie
- “LE GÉNÉRAL RABIN: jamais nous n'avons eu des frontières aussi aisées à défendre.” Le Monde, 1967, intervista a Yitzhak Rabin.
- “Address by Prime Minister Begin at the National Defense College.” Menachem Begin, 8 August 1982