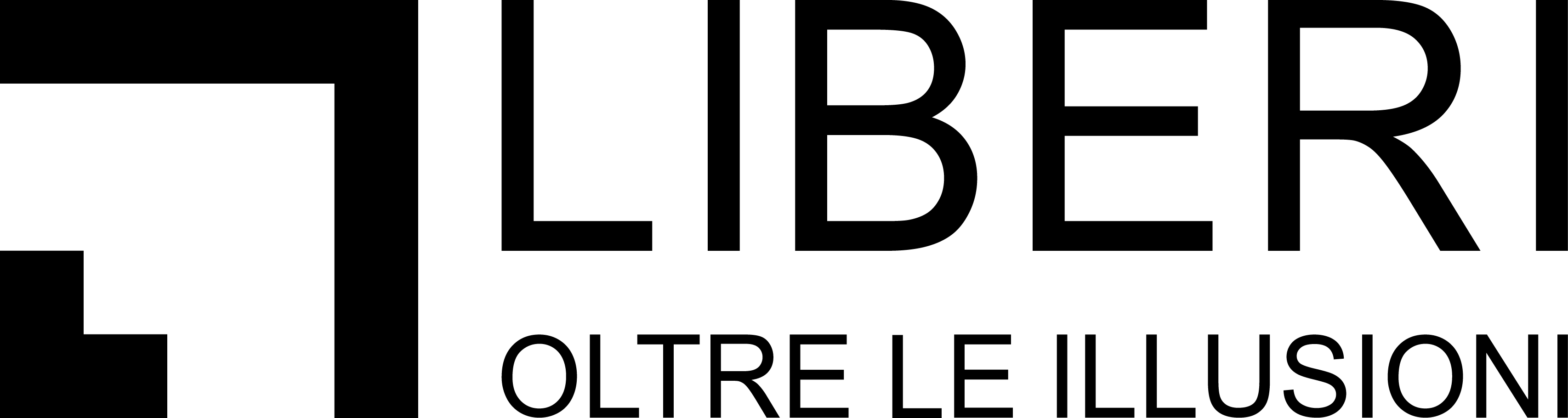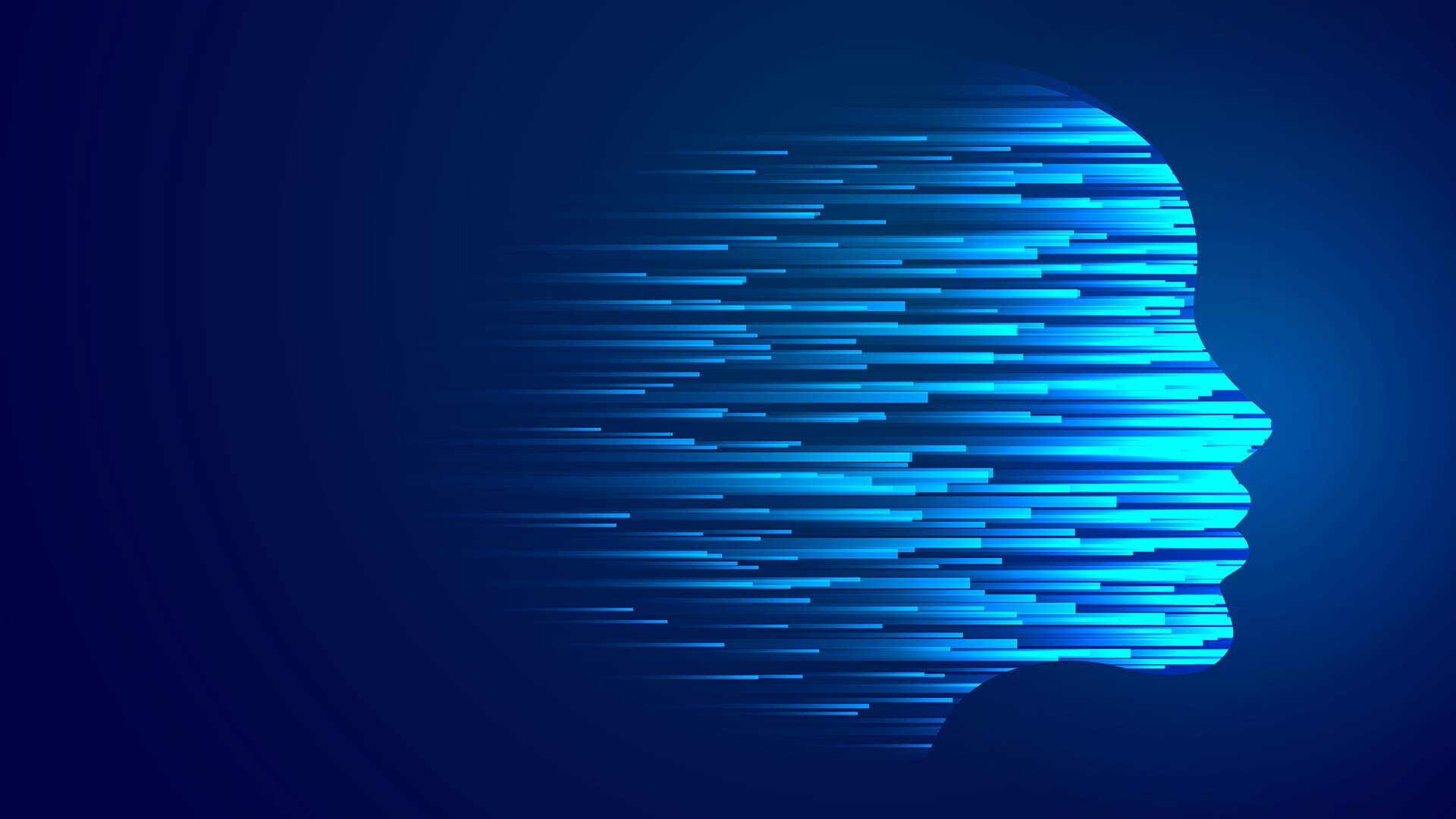Per “moralità” intendo qui non ciò che le persone credono sia moralmente giusto/sbagliato, ma ciò che è giusto/sbagliato (ometterò “moralmente” laddove ciò non possa creare fraintendimenti). Dico questo non per sostenere fin da subito che ciò che è giusto/sbagliato non sia solo una funzione di ciò che le persone credono sia giusto/sbagliato, ma perché, se la mia affermazione riguardasse semplicemente ciò che le persone credono, la questione sarebbe interamente socio-psicologica. Peraltro, penso sia ai limiti dell’ovvietà che, per qualunque tipo di credenza, sia relativo il fatto che le persone credano qualcosa, nel senso che dipende solo da loro se credono o no qualcosa. Questo è un punto spesso trascurato che porta le persone a parlare di “moralità” in due sensi diversi: uno soggettivo, riguardante il fatto che le persone abbiano certe credenze, e uno (che pretende di essere) oggettivo, riguardante ciò su cui si hanno delle credenze. Questa confusione, tra l’altro, mi sembra una conferma della prima cosa che ho detto, perché conferma che molti non trovano differenze tra parlare di moralità come di ciò che le persone credono e parlare di moralità come di ciò che è giusto/sbagliato.
In ogni caso, ciò che voglio discutere riguarda le ragioni che le persone comuni adducono per sostenere che ciò che è giusto/sbagliato sia relativo, ossia per sostenere che, nel senso oggettivo del termine “moralità”, la moralità sia relativa (di nuovo, che nel senso soggettivo del termine lo sia è pacifico praticamente per tutti). Ovviamente, questa tesi non è completa senza specificare a cosa la moralità sarebbe relativa, e questo può essere fatto dicendo che è relativa a una cultura, a uno Stato, a una famiglia, a un individuo o a qualcos’altro ancora. Dalla mia esperienza, le persone oscillano tra queste relativizzazioni a seconda del contesto di discussione; sono però spesso piuttosto ferme nel ritenere che qualche relativizzazione sia inevitabile. Questo non è subito apparente, perché, se si discute di problemi morali particolari, come se sia giusto sanzionare un Paese aggressore o se sia giusto donare in beneficenza, le persone sembrano non formulare i loro giudizi in merito relativizzandoli. Ed è anche verosimile (potete provare) che, se qualcuno rispondesse a un loro giudizio con “Ma X non sarebbe d’accordo” (dove “X” può stare per una cultura, uno Stato, un altro individuo, e così via...), la loro risposta non sarebbe che il loro giudizio è corretto solo in modo relativo, ma che X è nel torto. Eppure, se si tira fuori esplicitamente la questione della verità dei loro giudizi, sono subito pronte a mettere le mani avanti per dire cose del tipo “su queste cose non si può parlare di verità” o “questa è solo la mia opinione”. Quest’ultima risposta è un sintomo della confusione accennata poco fa, perché il fatto che qualcosa sia l’opinione di qualcuno è certamente relativo a quel qualcuno, ma non dice nulla sulla relatività di ciò su cui quel qualcuno ha un’opinione.
Ciò che vorrei fare in questa riflessione è valutare alcune di quelle che potremmo chiamare giustificazioni pre-teoriche del relativismo morale, ossia ragioni che le persone adducono per la loro tendenza/posizione relativista in ambito etico, senza però avere una teoria strutturata su cui basare le loro affermazioni. Dato che questo è lo scopo del saggio, probabilmente non dirò cose che un filosofo morale di professione non sappia già, ma trovo comunque utile far vedere che questa tendenza diffusa è sostanzialmente basata su errori e fraintendimenti, tanto del relativismo morale quanto delle posizioni antirelativiste. In questa sede mi concentrerò su due ordini di ragioni. Ovviamente, nella mia discussione ci sarà un certo grado di ricostruzione razionale degli argomenti, nel senso che proverò a presentare gli argomenti in una forma molto più esplicita e precisa di quanto solitamente venga fatto. Tuttavia, penso che tali ricostruzioni colgano il punto di ciò che si vuole sostenere quando cose simili vengono dette in dibattiti su questo tema. Spero, in questo modo, di trattare alcune delle giustificazioni che le persone normalmente hanno, o darebbero, a favore del relativismo morale.
L’argomento della diversità
Il primo tipo di argomento parte da un’affermazione di fatto circa le credenze delle persone. La tesi che potremmo chiamare relativismo empirico sostiene che, tanto nello stesso periodo storico e luogo quanto in periodi storici e luoghi diversi, le persone hanno credenze morali differenti e contrapposte. Questa è la versione più debole della tesi, ma alcuni fanno derivare già da essa il relativismo morale, assumendo che il relativismo empirico sia vero e che la migliore spiegazione per la sua verità sia il relativismo morale. Il ragionamento è che, se molte persone in luoghi e periodi storici diversi hanno credenze morali diverse, ciò accade perché non esistono verità morali non relative, in quanto, se ve ne fossero, dovremmo trovare maggiore coincidenza di opinioni in merito.
Questa versione della tesi è debole, perché l’assunzione che la verità del relativismo morale sia la migliore spiegazione della verità del relativismo empirico è facilmente contestabile. In generale, che esista un disaccordo di opinioni non è indice del fatto che non ci sia una verità che dia ragione a una parte e torto all’altra (o, in realtà, anche torto a entrambe). Possiamo capire che è così considerando il fatto che possiamo formulare una versione vera del relativismo empirico riguardante grossomodo qualsiasi cosa, non solo le credenze morali. Anche le credenze scientifiche sono soggette a molti disaccordi, sia in epoche diverse sia nel medesimo periodo storico. Questo è vero persino delle credenze matematiche (basti pensare alla scoperta delle geometrie non euclidee), ma pochi sarebbero disposti a ritenere che la migliore spiegazione di tali disaccordi sia l’inesistenza di verità non relative concernenti questioni scientifiche o matematiche. Piuttosto, quasi tutti direbbero che alcuni si sbagliavano e altri avevano ragione, anche se lo abbiamo scoperto solo in seguito o, per quanto riguarda le questioni aperte tutt’oggi, lo scopriremo in futuro (o almeno potremmo scoprirlo). Ma perché non si potrebbe dire esattamente la stessa cosa per l’etica? I disaccordi morali potrebbero esistere benissimo anche se ci fossero delle verità morali non relative, e qualcuno potrebbe avere ragione e altri essere nel torto, anche se le due parti continuassero a essere in disaccordo. Dal mero relativismo empirico sulle questioni morali, dunque, non segue il relativismo morale.
Si può però rafforzare il relativismo empirico con un’assunzione da cui sembrerebbe seguire il relativismo morale. Si potrebbe cioè dire che, dato il relativismo empirico e dato il fatto che, anche se due parti coinvolte in un disaccordo morale conoscessero tutti i fatti rilevanti in gioco, continuerebbero comunque a essere in disaccordo, segue che non è possibile in alcun modo sciogliere razionalmente il disaccordo; la migliore spiegazione di ciò sarebbe allora che non esistano verità morali non relative, tali per cui uno dei due abbia ragione e l’altro torto.[1] Ora, plausibilmente, questo argomento ha il vantaggio, rispetto al precedente, di non applicarsi alle questioni scientifiche. Se le due parti conoscessero tutti i fatti scientifici rilevanti in gioco, saprebbero come stanno le cose in merito alla questione su cui erano in disaccordo e capirebbero chi ha ragione e chi ha torto, potendo così sciogliere il disaccordo (assumendo che chi ha torto sia razionale abbastanza da riconoscere di avere torto quando lo viene a sapere).
Il problema di questo argomento è cosa si intende con “conoscere tutti i fatti rilevanti in gioco”, per il semplice fatto che, se tra questi fatti facciamo rientrare anche dei fatti morali, cioè qualcosa che renda veri certi giudizi morali, allora l’antirelativista morale può servirsi di una risposta analoga a quella data nel caso scientifico. Se infatti le due parti conoscessero tutti i fatti morali rilevanti in gioco (oltre a tutti i fatti non morali rilevanti), allora saprebbero come stanno le cose circa cosa sia giusto fare e capirebbero chi ha ragione e chi ha torto, potendo così sciogliere il disaccordo (nuovamente sotto la medesima assunzione di cui sopra). Se, d’altra parte, si escludono i fatti morali dai fatti rilevanti in gioco, l’assunzione fatta non pone alcun problema all’antirelativista, dato che non è strano che esista un disaccordo concernente questioni morali tra due individui che non conoscono tutti i fatti morali in gioco, così come non sarebbe strano che esistesse un disaccordo concernente questioni scientifiche tra due individui che non conoscono tutti i fatti scientifici in gioco. In nessuno dei due casi sarebbe impossibile sciogliere razionalmente il disaccordo, ma non è possibile di fatto se i due non conoscono tutti i fatti rilevanti in gioco, che nel caso di disaccordi morali comprenderebbero fatti morali. L’argomento che stiamo considerando è in effetti circolare, perché presuppone che non ci siano fatti morali in gioco e che, dato ciò, non sia possibile sciogliere razionalmente i disaccordi morali. Ma che non ci siano fatti morali, e dunque verità morali non relative, è precisamente ciò che l’argomento dovrebbe dimostrare, non presupporre.
Prima di chiudere questa sezione, vorrei sottolineare che riconosco che i disaccordi su questioni morali sono di fatto più persistenti e meno soggetti a essere sciolti razionalmente rispetto ai disaccordi scientifici. Come ho detto, ciò non stabilisce una differenza di principio tra i due, ma, a mio avviso, evidenzia un fatto contingente riguardante i giudizi morali. Essi sono infatti molto più permeabili a giudizi poco ponderati, emozioni non controllate, scelte personali e tanti altri fattori che influenzano il nostro modo di ragionare e l’essere disposti a riconoscere di avere torto. Disaccordi su casi riguardanti l’aborto, il consumo di carne, la pena di morte, ecc. ci coinvolgono emotivamente, e talvolta personalmente, molto più di quanto facciano la maggior parte delle questioni scientifiche. Che questi fattori giochino un ruolo importante nella persistenza del disaccordo lo vediamo dal fatto che quando certe questioni scientifiche assumono per noi una rilevanza analoga, anche in quei casi i disaccordi tendono a essere più persistenti. Gli esperti sono generalmente più in grado di controllare, sia individualmente che collettivamente, queste tendenze, ma non ne sono immuni nemmeno loro.[2] Inoltre, va sottolineato che alcuni disaccordi morali nascondono anche altri tipi di disaccordi. Ad esempio, la credenza, presente in certe popolazioni, che sia giusto effettuare sacrifici umani potrebbe essere in parte giustificata da credenze non morali di natura empirica e metafisica, come l’idea che il sacrificio sia in grado di scacciare le tempeste o di placare l’ira di una divinità. In questo caso, il disaccordo morale con chi negasse la legittimità di tale pratica potrebbe essere sciolto sciogliendo un disaccordo di natura non morale; tuttavia, anch’esso potrebbe non essere facile da sciogliere. Del resto, i casi di disaccordo sopra citati contengono ciascuno elementi di natura biologica, psicologica, sociologica e religiosa su cui molte indecisioni persistono.
Dunque, la mia ipotesi esplicativa per la differenza di persistenza nei disaccordi tra questioni morali e questioni scientifiche è che si tratti in parte di una differenza di coinvolgimento di fattori non razionali nella valutazione dei casi, e in parte di una percezione errata di dove il disaccordo sia davvero situato, dato che molte volte il disaccordo morale dipende da disaccordi di altra natura.
L’argomento delle eccezioni
Un secondo ordine di argomenti muove da una considerazione di tipo induttivo. L’idea è che a ogni principio morale che sia stato formulato sia possibile contrapporre dei casi che facciano da eccezione a quel principio e che dunque lo rendano inadeguato. In seguito, si fa una mossa induttiva e si sostiene che, poiché a ogni principio morale finora proposto sono sempre state trovate eccezioni, nessun principio morale vero sarà mai formulabile in modo non relativo. Per fare alcuni esempi, a un principio morale come il comandamento di non uccidere si contrappone il caso della legittima difesa; all’imperativo categorico kantiano di non mentire si contrappone il caso in cui si mente ai nazisti per proteggere degli ebrei nascosti in casa; al principio utilitarista di massimizzare il piacere complessivo si contrappone il caso del sadico il cui piacere supera il dolore provato dalla sua vittima. Un relativista potrebbe quindi dire che i princìpi morali, se sono veri, lo sono solo relativamente a certi casi; egli sosterrebbe dunque che, nella loro generalità, essi sono tutti falsi.
Ora, ci sono molte cose da dire su questo genere di argomenti. In primo luogo, anche in questo caso si può fare un discorso analogo per le questioni scientifiche. La forza di gravità è descritta correttamente dalla legge di gravitazione universale di Newton, ma solo relativamente a masse che si muovono a velocità lontane dalla velocità della luce e in assenza di campi gravitazionali troppo intensi; l’equazione di stato dei gas perfetti descrive correttamente il comportamento dei gas solo relativamente a pressioni non troppo elevate e a temperature non troppo vicine alla temperatura di liquefazione; la selezione naturale descrive correttamente la comparsa di molti tratti fenotipici, ma non di tutti. Ora, se dovessimo applicare la medesima mossa induttiva che abbiamo applicato nel caso dei princìpi morali, dovremmo dire che anche i princìpi scientifici attuali, in quanto presentano o presenteranno eccezioni, vanno relativizzati. Questo ci porterebbe a dire che nessun principio scientifico vero potrà mai essere formulato in modo non relativo.
Per rispondere a questo problema, iniziamo col chiederci in cosa consista la relativizzazione richiesta, in questo caso, dal relativista. In effetti, potremmo dire che enunciati come “La forza di gravità è descritta correttamente dalla legge di gravitazione universale di Newton, ma solo relativamente a masse che si muovono a velocità lontane dalla velocità della luce e in assenza di campi gravitazionali troppo intensi” sono veri non relativamente. Cioè: nella misura in cui incorporiamo le eccezioni dentro i princìpi, possiamo ottenere princìpi veri non relativamente. E allora potremmo fare la medesima cosa anche per i princìpi morali. Potremmo cioè formulare dei princìpi morali che incorporino tali eccezioni, ad esempio dicendo che è falso il principio “È sbagliato uccidere” ma è vero il principio “È sbagliato uccidere, ma solo se non è legittima difesa”.
Ci sono più modi di incorporare le eccezioni entro i princìpi (morali e non). Un modo è quello più immediato, ossia sostenere che il principio stesso contenga l’eccezione come parte di sé. Da un certo punto di vista, in questo modo il principio rimane privo di eccezioni, nel senso che un principio come “È sbagliato uccidere, ma solo se non è legittima difesa” non ha la legittima difesa come eccezione, poiché è parte del principio stesso che l’omicidio in caso di legittima difesa non sia sbagliato. A mio avviso, questo modo di incorporare le eccezioni nei princìpi presenta due difetti. Anzitutto, sembra riproporre il problema iniziale, ossia quello di trovare un principio privo di eccezioni, con l’unica differenza che stavolta ogni eccezione scovata viene aggiunta a porzioni di princìpi già dati, anziché venire esclusa da princìpi del tutto nuovi. In secondo luogo, perché aggiungere ai princìpi troppe eccezioni priva i princìpi di uno dei loro ruoli esplicativi. Un principio morale dovrebbe infatti dirmi perché certe azioni sono giuste/sbagliate (e dunque perché certi giudizi su di esse sono veri/falsi), ma un principio come “È sbagliato uccidere, ma solo se non è legittima difesa” non spiega perché l’omicidio in caso di legittima difesa non sia sbagliato. E se le eccezioni che un principio vero incorpora sono tante, come è verosimile che siano, esso finisce per non dire quasi nulla di esplicativo.
Un secondo modo per incorporare le eccezioni in un principio è quello di trattare i princìpi come princìpi prima facie. Un principio morale prima facie è un principio che fornisce una ragione per comportarsi in un certo modo, ma tale ragione non è sempre obbligante. Ad esempio, consideriamo il principio “È giusto mantenere le promesse”. Esso ci dice che abbiamo una ragione per mantenere le promesse o, in modo equivalente, che mantenere le promesse è un’azione “good-making”. Tuttavia, se esso è un principio prima facie, la sua verità non esclude che, in certi casi, l’azione da compiere sia rompere una promessa, perché altre ragioni possono subentrare e sovrastare la ragione che abbiamo per mantenerla. Ad esempio, se abbiamo promesso a un’amica di andare a casa sua a studiare, abbiamo una ragione prima facie per farlo; ma se per strada ci arriva una telefonata che ci dice che nostra madre si è sentita male ed è in ospedale, allora abbiamo una ragione per non andare a casa della nostra amica che sovrasta la nostra ragione per andarci. Si noti che, in quest’ottica, andare a casa della nostra amica rimane comunque un’azione “good-making”, ma in questo esempio subentra un’altra azione “good-making”, quella di andare a vedere come sta nostra madre in ospedale, che è preponderante rispetto alla prima. Questo modo di intendere i princìpi morali ha diversi vantaggi. Da un lato, tiene conto delle eccezioni e permette quindi di rispondere all’obiezione del relativista. In un certo senso, anche i princìpi prima facie sono privi di eccezioni, perché il valore di “good-making” delle azioni a cui si riferiscono è costante in tutte le circostanze (in tutte le circostanze rispettare una promessa è “good-making”). Allo stesso tempo, però, a seconda delle circostanze è possibile che altre azioni sovrastino certe azioni “good-making” e quindi siano esse a essere moralmente obbligatorie. Questo mostra come vi sia una differenza tra avere ragione di comportarsi in un certo modo ed essere moralmente obbligati a comportarsi in quel modo. I princìpi prima facie ci dicono soltanto che abbiamo ragione di comportarci in un certo modo. D’altra parte, questa concezione dei princìpi morali mantiene il loro ruolo esplicativo. L’idea, infatti, è che ogni azione moralmente rilevante sia tale che il suo valore è spiegato da qualche principio prima facie. Riprendendo l’esempio sopra, abbiamo ragione di andare dall’amica (andare dall’amica è “good-making”) perché è giusto rispettare le promesse; e abbiamo ragione di andare in ospedale a trovare nostra madre (andare a trovare nostra madre è “good-making”) perché è giusto assistere le persone in difficoltà.[3]
Ora, davanti a questo modello dei princìpi morali, il relativista potrebbe pensare di trovare terreno fertile per reiterare la sua critica. È chiaro infatti che questo modello consente un confronto tra princìpi morali veri non in contrasto, ma tali per cui certe azioni da essi indicate come “good-making” non possono essere compiute simultaneamente. È necessario quindi capire quale delle ragioni per agire sia preponderante rispetto all’altra. Il relativista potrebbe allora sostenere che qui si ripresenta il problema per cui un principio ci dice di fare qualcosa, ma un caso ci dice di non farlo. A ciò si può tuttavia rispondere che la difficoltà non è più di natura induttiva, cioè di trovare un principio che escluda quel caso, ma che in realtà sia necessario solo indagare la situazione concreta e vedere quali ragioni sono in gioco. Il discorso è analogo a quello che accade quando ci chiediamo perché un certo fenomeno sia avvenuto. Se ammettiamo che ci siano leggi di natura che regolano l’accadere dei fenomeni, verosimilmente un certo fenomeno accadrà per via di numerose leggi. Un oggetto che cade da un tavolo cade in virtù della legge di gravitazione, ma anche in virtù delle leggi che governano l’attrito tra l’oggetto e l’aria, nonché di quelle che governano l’attrazione elettromagnetica (se l’oggetto è metallico e attirato da un magnete) e così via. Quali siano le leggi in gioco in un caso specifico non è ovvio (infatti le dobbiamo scoprire) e, di conseguenza, non è ovvio quali siano le cause preponderanti che hanno portato l’oggetto a cadere anziché a rimanere sul tavolo.[4] Lo stesso possiamo dire per le ragioni che abbiamo per comportarci in un certo modo. I princìpi in gioco non sono ovvi e non è ovvio quindi quale sia preponderante. Tuttavia, per capirlo non ci serve trovare princìpi privi di eccezioni; occorre piuttosto guardare a cosa accade nella situazione specifica che stiamo valutando.
Conclusioni
Vorrei concludere facendo notare, come dovrebbe già risultare chiaro da quanto ho sostenuto, che il rapporto tra etica e scienza è molto più stretto di quanto si possa pensare. Ho mostrato che molte delle minacce all’antirelativismo morale sono ricostruibili anche come minacce all’antirelativismo scientifico e che le risposte che un antirelativista in etica può dare al relativista morale non sono poi molto diverse da quelle che può dare un antirelativista scientifico a un relativista corrispondente. Ma, in realtà, si può dire anche di più. L’etica è notoriamente una disciplina normativa, ossia una disciplina che ci dice cosa dovremmo fare.[5] Molti ritengono che una distinzione fondamentale tra etica e scienza consista nel fatto che a quest’ultima manchi la componente normativa. Si ritiene che la scienza sia una disciplina puramente descrittiva e che quindi essa non faccia alcun appello a considerazioni su come le cose dovrebbero stare, ovvero a considerazioni normative. Questo pensiero, tuttavia, non tiene conto di un punto di cui gli epistemologi sono consapevoli ormai da lungo tempo, e cioè che alla base di ogni discorso conoscitivo vi sono delle norme che ci dicono cosa dovremmo credere e cosa no. Queste norme sono solitamente note come virtù epistemiche e comprendono cose come la coerenza, l’aderenza alle evidenze, la parsimonia concettuale, la capacità esplicativa, e varie altre. Dire che non dovremmo credere a una certa teoria perché è incoerente è un’affermazione normativa. Allo stesso modo, dire che un’evidenza contraria a una teoria è una ragione per rifiutare la teoria è un’affermazione normativa, poiché ciò che abbiamo ragione (in definitiva) di credere è ciò che dovremmo credere (si noti che avere ragioni per credere qualcosa è parallelo ad avere ragioni per comportarsi in un certo modo). È inoltre impossibile giustificare qualunque credenza senza fare appello a qualche virtù epistemica, dato che è proprio il fatto di possedere virtù epistemiche a rendere una credenza giustificata e, se vera, conoscenza. Ne segue quindi che la normatività non è davvero un tratto in grado di distinguere l’etica da imprese di ricerca della verità come le scienze (sebbene si possa ritenere che la normatività morale non si riduca alla normatività epistemica).[6]
Andrebbe infine notato che le scienze devono affidarsi a princìpi di base che non sono in grado di giustificare da sé, come, ad esempio, l’assunzione secondo la quale la percezione sarebbe una fonte di conoscenza affidabile, anziché essere preda di uno scenario scettico in cui ogni credenza formata a partire da percezioni risulterebbe falsa. Come fare a giustificare tale assunzione non è qualcosa di cui normalmente ci preoccupiamo, ma questo non vuol dire che sia un’impresa più facile rispetto a quella di giustificare i princìpi più fondamentali dell’etica;[7] anche da questo punto di vista, dunque, etica e scienza si trovano su un terreno molto simile. Alla luce di questi forti parallelismi e dato che sono convinto dell’oggettività della scienza, ritengo che l’idea secondo cui anche l’etica sia oggettiva non sia così implausibile dopo tutto.[8]