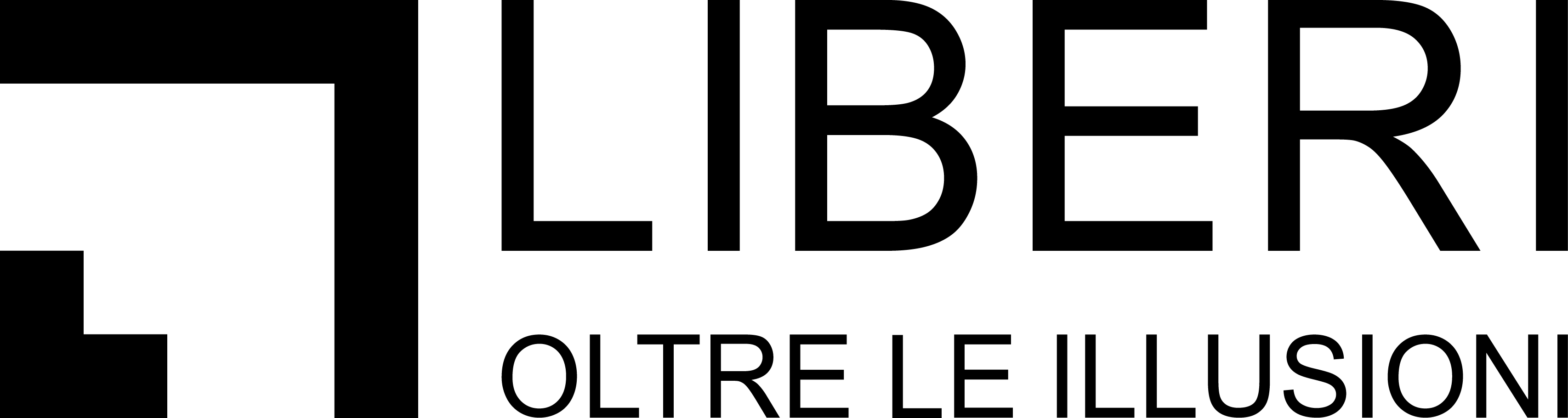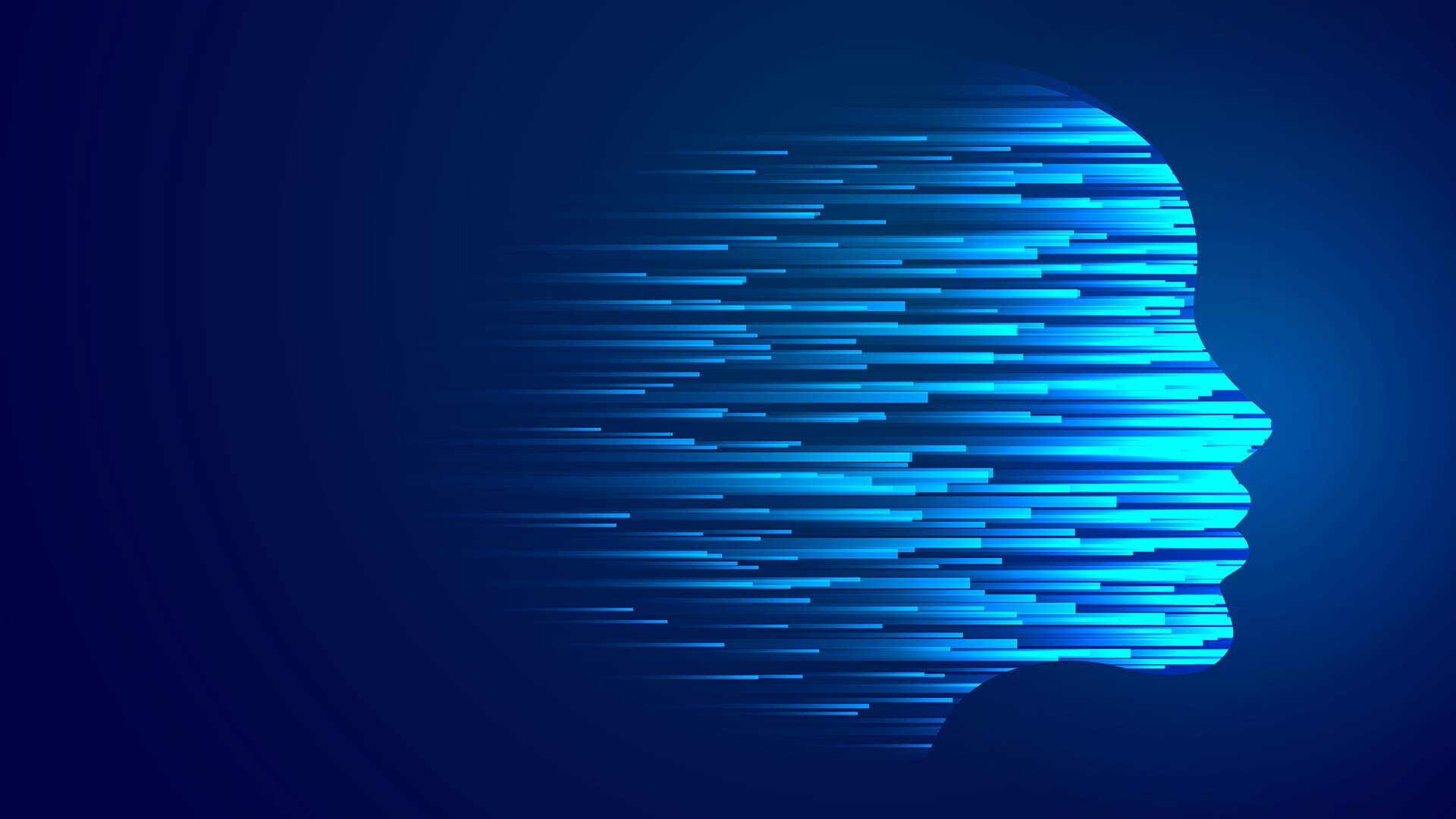Il referendum e la democrazia tradita
Viviamo in una democrazia che si è abituata a ignorare sé stessa. Tra le sue espressioni più pure, il referendum abrogativo è diventato – nell'immaginario collettivo – una formalità, un gesto sterile, un appuntamento marginale per giuristi incalliti o per militanti nostalgici.
Eppure, nella sostanza, il referendum è lo strumento più potente che una Repubblica possa offrire ai suoi cittadini: non una delega, ma una scelta. Non un “voto per”, ma un “voto su”. Una legge, una norma, una questione concreta. È la possibilità di dire: «Questa legge non mi rappresenta. E voglio che venga cancellata».
Questa potenza democratica – la più alta forma di partecipazione diretta prevista dalla nostra Costituzione – è oggi svilita da una realtà drammatica: l’astensionismo. Alle ultime tornate referendarie, come quella del giugno 2022, l’affluenza si è fermata ben al di sotto del quorum. Un fallimento di partecipazione che, più che disinteresse, racconta forse una sfiducia, un malessere cronico che affonda le radici in una cultura politica fragile, nella disillusione verso le istituzioni, e in un deficit educativo che ha smesso di insegnare il valore della cittadinanza attiva.


Basta soffermarsi sui numeri: nel 2022, solo il 20,9% degli aventi diritto è andato a votare sui cinque quesiti referendari in materia di giustizia. Un crollo verticale rispetto a stagioni passate, quando i referendum mobilitavano coscienze, piazze, visioni del mondo. E se analizziamo i dati per fasce d’età, il quadro è ancora più inquietante: i più giovani – tra i 18 e i 34 anni – sono i grandi assenti. Ma non perché siano indifferenti, quanto perché sentono che la politica non parla più la loro lingua, e che la loro partecipazione si perde in un oceano di inefficacia sistemica.
Con tutte le forze occorre evitare che la democrazia si trasformi in una maschera ipocrita del potere, una finzione che dà al cittadino l’illusione di contare, quando in realtà è del tutto marginale rispetto alle reali decisioni politiche, economiche e sociali.
E questa, che piaccia o no, è una buona occasione. Perché il referendum è, ancora oggi, il più forte strumento di una democrazia.
Cinque quesiti, una doppia direzione: lavoro e cittadinanza
L’8 e il 9 giugno si vota su cinque referendum abrogativi: strumenti di democrazia diretta con cui i cittadini possono cancellare una legge, o una parte di essa. Perché il voto sia valido, serve che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Un quesito riguarda la cittadinanza italiana, gli altri quattro toccano il mondo del lavoro, tra tutele, contratti e sicurezza.
I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. Possono votare anche i fuori sede che ne hanno fatto richiesta entro il 5 maggio, i cittadini iscritti all’AIRE e chi si trova temporaneamente all’estero per lavoro, studio o salute (se ha fatto domanda entro il 7 maggio).
Quesito 1 – Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi
Il primo quesito referendario dell’8 e 9 giugno riguarda le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act nel 2015, una riforma del mercato del lavoro voluta dal governo Renzi con l’obiettivo di rendere più flessibili i rapporti di lavoro.
Attualmente, per i dipendenti delle aziende con più di 15 lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 – data di entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act – il reintegro nel posto di lavoro è previsto solo in casi eccezionali, come i licenziamenti discriminatori o nulli. Negli altri casi, anche se il licenziamento è dichiarato ingiustificato, il lavoratore ha diritto soltanto a un’indennità economica. Il referendum propone di abrogare le norme che limitano il reintegro, estendendo anche a questi lavoratori la possibilità di essere reintegrati nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, come già previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per chi è stato assunto prima di quella data (ovvero prima del 7 marzo 2015).
Va precisato che il contratto a tutele crescenti non ha creato una nuova tipologia contrattuale, ma ha modificato il regime sanzionatorio applicabile in caso di licenziamento senza giusta causa. La riforma ha dunque affiancato – senza sostituirlo integralmente – l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile ancora oggi ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. In virtù del principio di irretroattività delle leggi, questa differenziazione è stata ammessa dal legislatore, creando tuttavia due regimi distinti e potenzialmente iniqui per situazioni analoghe.
Di fatto, dunque, si è creata una (apparente) disparità di trattamento tra lavoratori “vecchi” e “nuovi”, con una maggiore protezione per i primi. Tuttavia, questa disuguaglianza è stata progressivamente attenuata grazie a una serie di interventi della Corte costituzionale, che – già a partire dal 2018 e, più recentemente, con le sentenze n. 22/2024 e n. 128/2024 – ha ritenuto eccessivamente rigida e automatica l’applicazione esclusiva dell’indennizzo. Le pronunce hanno restituito ai giudici maggiore margine di valutazione e, in alcuni casi, hanno riaperto alla possibilità di reintegro anche per i lavoratori assunti dopo il 2015 qualora il licenziamento risulti manifestamente infondato o arbitrario.
Chi è favorevole al Sì ritiene che le tutele attualmente previste per i lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti siano ancora insufficienti, e che sia necessario ristabilire pienamente l’equità tra tutti i lavoratori, eliminando una distinzione basata esclusivamente sulla data di assunzione. Per i sostenitori del Sì, quindi, restituire ai giudici la possibilità di disporre il reintegro anche nei casi di licenziamento economico ingiustificato – e non solo in quelli discriminatori – potrebbe rafforzare il principio di giustizia sostanziale e potrebbe garantire una tutela più concreta contro gli abusi.
Chi sostiene il No, invece, sottolinea come il Jobs Act abbia introdotto maggiore certezza e prevedibilità nelle relazioni di lavoro, semplificando le scelte per le imprese e favorendo la competitività del sistema economico. Secondo questa posizione, reintrodurre l’obbligo di reintegro anche per i licenziamenti economici giudicati illegittimi aumenterebbe l’incertezza giuridica, renderebbe più rischiose le assunzioni a tempo indeterminato e potrebbe avere effetti disincentivanti sull’occupazione.
Il quesito, in definitiva, interroga ciascun elettore su quale bilanciamento ritenga più giusto tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dei diritti del lavoratore, due principi fondamentali entrambi tutelati dalla Costituzione, ma spesso in tensione tra loro.
Quesito 2 – Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità
Il secondo quesito referendario riguarda le cosiddette “piccole imprese”, ossia quelle con meno di 15 dipendenti, e in particolare il tetto massimo previsto per l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.
Secondo la legge n. 604 del 1966, attualmente, un lavoratore licenziato ingiustamente da un’azienda di queste dimensioni ha diritto a un risarcimento che non può superare le sei mensilità, indipendentemente dalla gravità del licenziamento o dalle condizioni personali ed economiche del lavoratore.
Il quesito propone di abrogare questo limite, lasciando al giudice la possibilità di stabilire un risarcimento proporzionato al singolo caso, tenendo conto anche della situazione economica dell’impresa. Si tratterebbe, dunque, di passare da una soglia fissa a una valutazione più flessibile e personalizzata.
Il tema è tutt’altro che semplice. Da un lato, basare l’intero sistema di tutele esclusivamente sul numero dei dipendenti appare oggi anacronistico: esistono realtà con meno di 15 lavoratori ma con fatturati milionari, che poco hanno a che vedere con la fragilità delle microimprese. Dall’altro lato, però, l’eliminazione di un tetto predefinito potrebbe creare un’elevata incertezza per le aziende, lasciando la quantificazione del danno interamente alla discrezionalità del giudice. Non è escluso che, nel fissare il limite delle sei mensilità, il legislatore del 1966 volesse proprio fornire una forma di certezza agli imprenditori più piccoli.
Chi vota Sì ritiene che la modifica possa garantire maggiore equità, superando una disparità fondata unicamente sul numero di dipendenti e adattando la tutela al caso concreto, senza trascurare la reale struttura economica dell’impresa.
Chi vota No, al contrario, teme che l’abrogazione del tetto possa tradursi in un aggravio di costi e contenziosi per le microimprese, esponendole a un’eccessiva incertezza giuridica. Anche in questo caso, la critica si concentra sul fatto che si continui a ragionare in base al numero di dipendenti, senza considerare l’effettiva dimensione economica dell’azienda. Rimettere ogni valutazione nelle mani del giudice significa anche introdurre margini di incertezza non solo per l’imprenditore e il lavoratore coinvolto, ma anche per gli altri dipendenti dell’azienda, che potrebbero trovarsi esposti a un clima di instabilità.
In definitiva, è certamente necessario rivedere una norma datata (1966) che considera il solo numero dei dipendenti come parametro di riferimento, ma farlo in modo semplicistico potrebbe essere assai pernicioso. Servirebbe, piuttosto, una riforma calibrata e ben bilanciata, capace di tutelare allo stesso tempo i diritti del lavoratore e la sostenibilità delle piccole realtà produttive.
Quesito 3 – Causale e contratti a termine
Il terzo quesito referendario riguarda la disciplina dei contratti a tempo determinato, una delle aree più controverse e delicate del mercato del lavoro, perché strettamente connessa al tema della precarietà.
Secondo la CGIL, promotrice del referendum, l’abuso sistematico di contratti a termine ha contribuito in modo significativo a creare una condizione di instabilità strutturale per molti lavoratori. L’obiettivo dichiarato è dunque quello di limitare l’utilizzo dei contratti temporanei, scoraggiandone l’uso improprio e incentivando al contrario le assunzioni a tempo indeterminato.
Attualmente, la materia è regolata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che consente di stipulare un primo contratto a tempo determinato fino a 12 mesi senza obbligo di causale, cioè senza indicare alcuna motivazione. La causale diventa obbligatoria soltanto in caso di rinnovo o proroga oltre l’anno. Le causali previste possono derivare dal contratto collettivo nazionale (CCNL) oppure, in sua assenza, essere individuate tra esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, o ancora per la sostituzione di un lavoratore assente.
Questa disciplina ha subito numerose modifiche nel tempo: l’obbligo di causale per i contratti brevi era stato eliminato nel 2015 con il Jobs Act (governo Renzi), poi reintrodotto nel 2018 con il Decreto Dignità (governo Conte) e infine ulteriormente rivisto nel 2023 dal Decreto Lavoro (governo Meloni), che ha rimosso nuovamente l’obbligo per i contratti fino a 12 mesi e ridefinito le causali per i contratti tra i 12 e i 24 mesi.
Il quesito referendario propone ora di reintrodurre l’obbligo di causale fin dal primo contratto, con l’intento di rendere più stringenti le condizioni per l’attivazione di rapporti a termine e rafforzare le garanzie contro l’uso strumentale della flessibilità.
Chi vota Sì ritiene che questa misura possa contribuire in modo concreto a contrastare la precarietà, assicurando maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro e riducendo il ricorso a contratti brevi usati come soluzioni permanenti. L’auspicio è che, rendendo più oneroso e motivato il contratto a termine, si spinga il sistema produttivo verso una maggiore stabilità occupazionale.
Chi invece sceglie il No teme che l’obbligo di motivare ogni assunzione sin dal primo contratto possa irrigidire eccessivamente il mercato del lavoro, soprattutto per quelle imprese che hanno reali necessità temporanee, come stagionalità, picchi di produzione o sostituzioni. Una maggiore rigidità, secondo questa visione, potrebbe scoraggiare le assunzioni e ridurre complessivamente la capacità del sistema di adattarsi ai cambiamenti.
Il quesito solleva una questione centrale: quale equilibrio vogliamo mantenere tra le esigenze organizzative delle imprese e la stabilità delle condizioni lavorative?
Ma, soprattutto: siamo davvero certi che limitare la flessibilità possa tradursi automaticamente in più occupazione e meno precarietà? O rischiamo di colpire un sintomo senza risolvere la causa?
Quesito 4 – Responsabilità solidale negli appalti e subappalti
Il quarto quesito referendario riguarda la responsabilità nei casi di infortunio sul lavoro all’interno dei contratti di appalto e subappalto, un ambito spesso poco noto ma centrale per la tutela dei lavoratori coinvolti nelle filiere produttive.
Per comprendere il senso del quesito, è utile chiarire cosa si intende per appalto e subappalto. Si parla di appalto quando un’azienda o una stazione appaltante (committente) affida a un’impresa terza (appaltatore) la realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio, in cambio di un corrispettivo. L’appaltatore, a sua volta, può delegare parte dell’attività a un’altra impresa (subappaltatore), creando così una catena articolata composta da tre soggetti: committente, appaltatore, subappaltatore.
In questa catena, esiste già una forma di responsabilità solidale del committente per determinati obblighi dell’appaltatore, ad esempio quelli di natura retributiva, contributiva e assicurativa. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento, il lavoratore può rivalersi sia sull’appaltatore che direttamente sul committente, aumentando così le sue garanzie.
Questa responsabilità solidale non si estende però automaticamente ai casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando questi derivano da rischi specifici dell’attività svolta dall’appaltatore. In questi casi, attualmente, solo il datore di lavoro diretto (cioè l’appaltatore) è chiamato a rispondere del danno, mentre la committente resta esclusa.
Immaginiamo che una catena di supermercati affidi a un’impresa esterna la manutenzione degli impianti elettrici nei propri punti vendita. Se un elettricista dell’impresa appaltatrice, durante un intervento, rimane folgorato a causa di un malfunzionamento di un quadro elettrico, il rischio è considerato tipico dell’attività svolta dall’appaltatore. Secondo la normativa attuale, la responsabilità per l’infortunio ricade esclusivamente sull’impresa che ha assunto il lavoratore, mentre la committente – pur beneficiando del servizio – non risponde in solido per il danno.
Il quesito referendario propone di abrogare questa eccezione, estendendo la responsabilità solidale del committente anche a questi casi. In altre parole, anche se il rischio è tipico e specifico dell’attività dell’appaltatore, la committente sarebbe comunque corresponsabile per i danni subiti dal lavoratore.
Chi sostiene il Sì ritiene che la modifica possa rafforzare concretamente la tutela dei lavoratori, migliorando la prevenzione e incentivando le aziende committenti a scegliere con maggiore attenzione i propri partner e a vigilare sulle condizioni di sicurezza lungo tutta la filiera. Secondo questa visione, la sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa, e chi trae vantaggio dall’attività lavorativa deve anche assumersi parte dell’onere di proteggerla.
Chi invece vota No teme che l’estensione della responsabilità solidale possa generare un aumento dei costi, della burocrazia e del contenzioso, anche nei casi in cui la committente non abbia alcuna colpa diretta. Si solleva, inoltre, la preoccupazione che questa misura possa disincentivare l’esternalizzazione di servizi o opere, ostacolando l’operatività di molte imprese.
Il quesito pone, in definitiva, una domanda cruciale: quanto deve essere coinvolta l’azienda che affida un’attività nel garantire la sicurezza di chi la esegue, anche se non è un proprio dipendente diretto?
È una questione di giustizia, ma anche di sostenibilità del sistema produttivo.
Quesito 5 – Modifica del termine di residenza per la cittadinanza
È il quesito più discusso e simbolicamente più carico. Secondo la Legge 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. È quanto stabilisce, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera f), che definisce la naturalizzazione.
In pratica, tra tempi burocratici e verifiche, si arriva spesso a 13 anni. Oltre al requisito temporale, servono anche conoscenza della lingua italiana, reddito stabile e assenza di condanne penali.
Il referendum propone di ridurre il requisito temporale da dieci a cinque anni. La misura riguarderebbe circa 2,3 milioni di persone e renderebbe trasmissibile la cittadinanza ai figli minorenni.
Chi vota Sì ritiene che cinque anni siano un periodo sufficiente per valutare l’effettiva integrazione di una persona nella società italiana. Vuole abbreviare l’attesa per chi dimostra di vivere regolarmente, lavorare, pagare le tasse e rispettare le regole. La cittadinanza, in questa prospettiva, diventa uno strumento di inclusione e stabilizzazione, non un privilegio da procrastinare.
Chi, invece, vota No, ritiene che dieci anni siano un termine ragionevole per consentire una valutazione approfondita e responsabile dell’integrazione, della condotta e della reale volontà di appartenenza. Teme che la riduzione del tempo possa rendere troppo accessibile un diritto che ha conseguenze politiche, civiche e identitarie importanti.
Se dovesse prevalere il sì, la nuova formulazione dell’art. 9, comma 1, sarebbe: “La cittadinanza italiana può essere concessa […] allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni”.
Su questo punto è importante chiarire alcuni fraintendimenti. Alcuni oppositori del Sì – spesso contrari a qualsiasi forma di riforma sulla cittadinanza – sostengono che la modifica aprirebbe indiscriminatamente la porta alla cittadinanza per tutti gli immigrati, anche irregolari. Ma ciò, ovviamente, non corrisponde al vero.
Come urlava Nanni Moretti seduto a bordo piscina nel film “Palombella rossa”: le parole sono importanti.
E nel diritto, lo sono ancora di più.
“Risiedere legalmente” non è un’espressione vaga. Significa:
- Essere iscritti all’anagrafe di un Comune italiano;
- Avere un permesso di soggiorno valido e in regola;
- Vivere stabilmente in Italia, salvo assenze brevi e giustificate.
Chi è entrato illegalmente e non ha mai regolarizzato la propria posizione non rientra in questa definizione. Il referendum non introduce automatismi né amnistie: si rivolge solo a chi è già parte integrante del tessuto sociale italiano.
Va inoltre precisato che la disciplina vigente già contempla alcune eccezioni al termine decennale, sempre previste dall’articolo 9 della legge 91/1992.
La cittadinanza può infatti essere concessa:
- Allo straniero il cui padre, madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sia stato cittadino italiano per nascita, oppure a chi è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno tre anni (art. 9, comma 1, lettera a));
- Al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che risieda legalmente in Italia da almeno quattro anni (art. 9, comma 1, lettera d));
- All’apolide che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni ((art. 9, comma 1, lettera e)).
In relazione a quest’ultimo punto, l’articolo 16, comma 2, della medesima legge equipara al soggetto apolide anche lo straniero riconosciuto rifugiato secondo la normativa nazionale o internazionale. Pertanto, anche i rifugiati possono ottenere la cittadinanza se risiedono legalmente in Italia da almeno cinque anni.
In conclusione, il quinto quesito referendario invita a riflettere sul significato della cittadinanza e sui criteri con cui essa viene concessa. La proposta di ridurre da dieci a cinque anni il requisito di residenza legale non rappresenta una rivoluzione del sistema, ma una modifica di tipo temporale, che lascia inalterati tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, come la regolarità del soggiorno, la stabilità economica, la conoscenza della lingua e l’assenza di condanne penali.
Conclusione
Sia nel mondo del lavoro che in quello della cittadinanza, emerge con forza un’esigenza di cambiamento profondo. Un cambiamento che, da solo, questo referendum non potrà realizzare, anche nell’ipotesi di una vittoria del Sì. I problemi in gioco sono infatti strutturali, complessi e intrecciati con dinamiche politiche, economiche e culturali di lungo corso.
Eppure, partecipare al voto resta un gesto importante. Non tanto per la portata immediata dell’esito, quanto per il messaggio che può lanciare: quello di una società viva, consapevole, desiderosa di essere protagonista del proprio futuro.
Il compito del cambiamento non può gravare solo sulle istituzioni. Le forze politiche devono tornare a parlare il linguaggio del Paese reale. I sindacati, da parte loro, hanno la responsabilità di trasformare le istanze delle piazze in azioni concrete e durature. Ma la responsabilità più grande ricade proprio sui cittadini, chiamati a non limitarsi al solo gesto elettorale.
Perché, è bene ricordarlo, il voto è solo l’inizio. La partecipazione democratica è un processo continuo che richiede attenzione, confronto, presenza. Come affermava Aldo Moro: “La democrazia non è soltanto una somma di procedure, né si esaurisce nell’atto del voto. Essa è partecipazione responsabile e continua alla vita della comunità.”
Il non voto e, dunque, l’astensione dal voto è una scelta legittima. Discutibile, ma legittima. Una scelta, però, che dovrebbe essere individuale e non suggerita da un partito per un mero gioco politico.
E invece, oggi, i partiti di maggioranza stanno spingendo esplicitamente in questa direzione: non spiegano i quesiti, non li affrontano nel merito, ma li ignorano strategicamente. Sostengono che anche l’astensionismo sia un “voto”, un segnale politico, quando in realtà è solo un modo per svuotare di senso la partecipazione popolare.
Il loro obiettivo è chiaro: evitare che i propri elettori vadano alle urne, per trasformare un eventuale fallimento del quorum in una sconfitta dell’opposizione. Ma così facendo, il referendum diventa solo un terreno di scontro tra apparati, non più uno spazio di decisione per i cittadini. E la democrazia, ancora una volta, viene ridotta a una tattica.
Le recenti dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ne sono un esempio lampante. Durante un evento a Firenze, La Russa ha affermato: «Farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa». Un invito esplicito all’astensione, che ha suscitato forti reazioni da parte delle opposizioni. Anche il vicepremier Antonio Tajani ha invitato i cittadini a non recarsi alle urne, sostenendo che «non andare a votare è una scelta politica».
Ma trasformare l’astensione in una strategia deliberata significa minare alla radice il principio stesso della democrazia partecipata. Il messaggio che ne deriva è pericoloso: non discutere nel merito, non confrontarsi sui contenuti, non attivare il cittadino, ma disinnescarlo. Disattivarlo. Trattarlo come un elettore da tenere a casa, non come un soggetto pensante da coinvolgere.
È in questo vuoto di responsabilità – culturale prima ancora che politica – che il referendum rischia di affondare. Non per la complessità dei quesiti, ma per la complicità di chi dovrebbe tutelare la partecipazione, e invece la sabota.
Votare non è un atto sacro, ma è un atto serio. E in democrazia, ogni atto serio ha un peso.
Il referendum non è perfetto, non è risolutivo, non è facile. Ma è uno degli strumenti più diretti che abbiamo per contare davvero. E oggi, quando chi è al potere ci dice che è meglio non usarlo, proprio oggi vale la pena ricordare che ogni astensione chiesta dall’alto è un potere tolto dal basso.
L’8 e 9 giugno non si tratta solo di esprimersi su cinque norme. Si tratta di decidere se vogliamo che la nostra voce abbia ancora un senso.
Non votare è una scelta. Ma votare – oggi – è una presa di posizione. È dire: io ci sono, e voglio decidere.