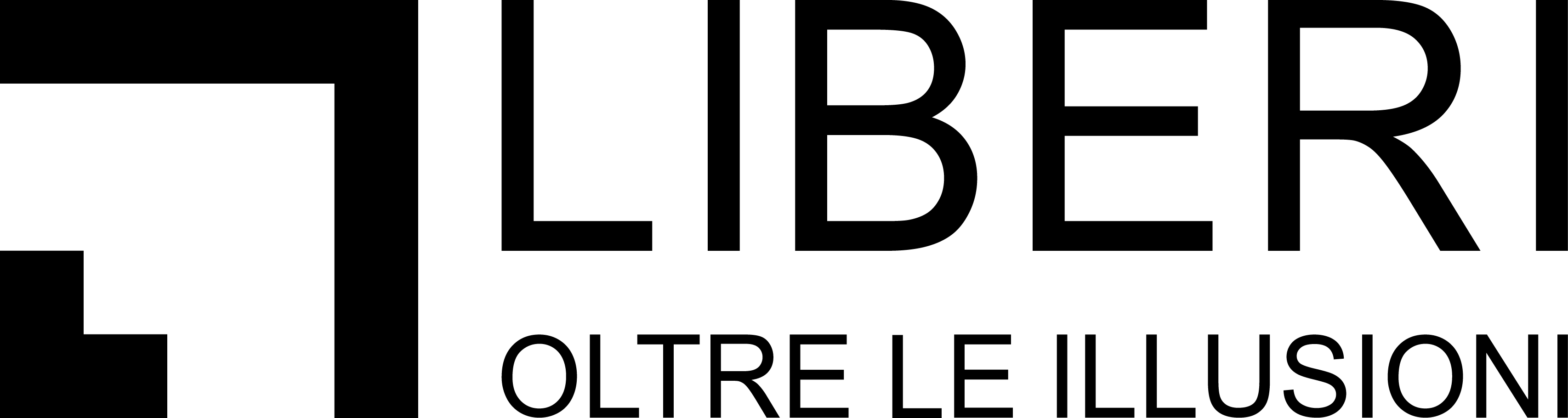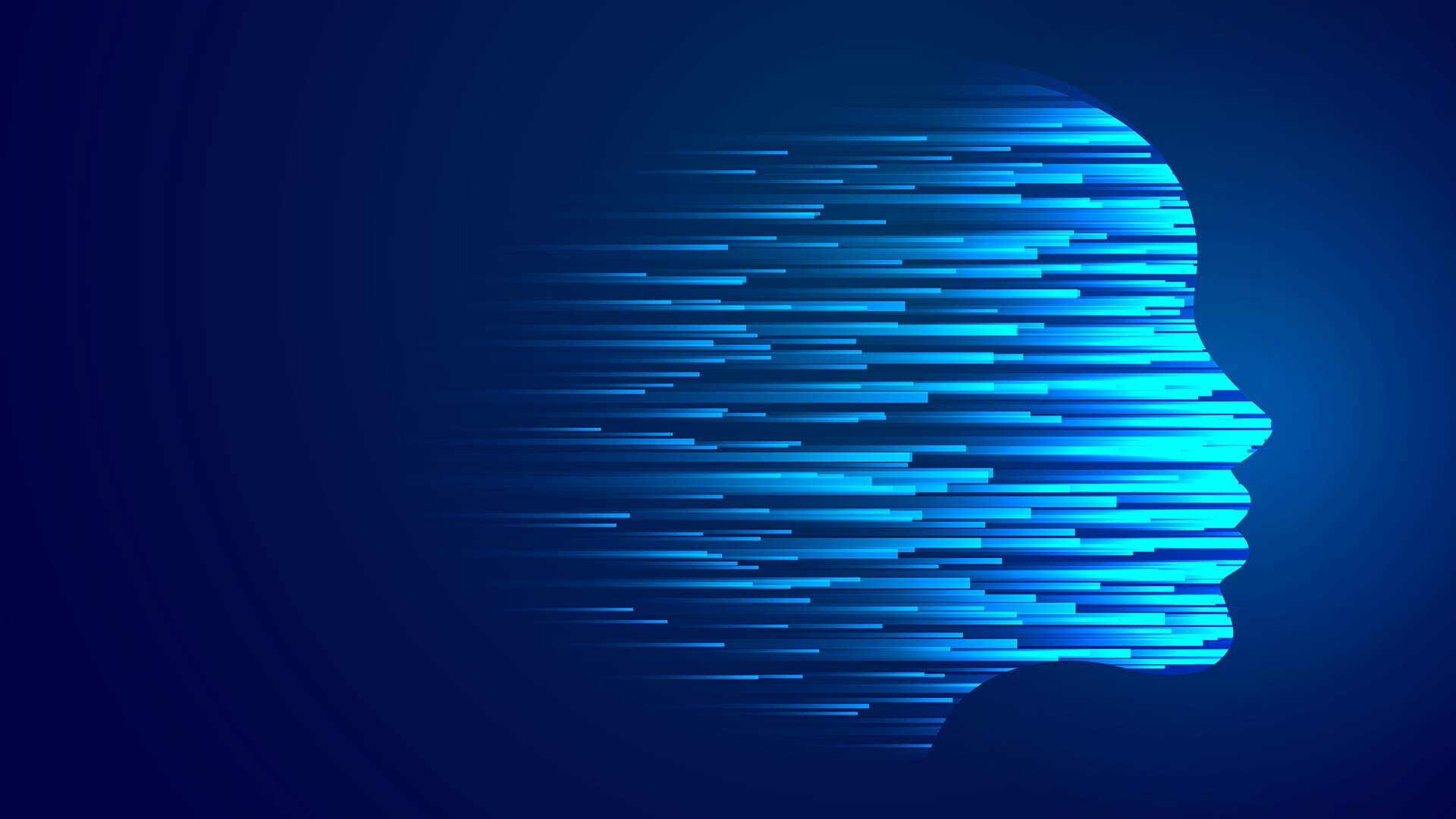Nel dibattito internazionale sul conflitto israelo-palestinese, è sempre più frequente assistere a un uso distorto e intellettualmente scorretto del concetto di antisemitismo (1). Questo termine, che porta con sé il peso di secoli di persecuzioni, culminati nella catastrofe della Shoah, viene oggi impiegato — e spesso strumentalizzato — per squalificare ogni critica rivolta allo Stato d’Israele e, in particolare, alle sue politiche nei confronti del popolo palestinese. In prima linea in questo processo vi è il governo di Benjamin Netanyahu, che ha sistematicamente equiparato le voci critiche, interne ed esterne, ad atti di odio contro gli ebrei, etichettando come “antisemita” ogni forma di dissenso verso la condotta militare, le politiche di colonizzazione, o l’oppressione dei civili palestinesi.
Questa equiparazione non è solo un errore politico e una scorrettezza logica; è, soprattutto, un'offesa profonda alla memoria storica delle vittime del vero antisemitismo e un atto di violenza simbolica nei confronti di migliaia di ebrei — pensatori, attivisti, religiosi, pacifisti — che si oppongono da decenni a tali politiche nel nome di una più alta fedeltà ai principi etici dell’ebraismo.
La confusione concettuale che sta alla base di questa retorica nasce da un errore fondamentale: identificare lo Stato d’Israele con l’intero popolo ebraico, e la critica allo Stato con l’odio verso gli ebrei. Questa equazione è storicamente e filosoficamente insostenibile. L’ebraismo è una tradizione religiosa e culturale millenaria, caratterizzata da una straordinaria pluralità interna. Non è un monolite, ma un mosaico di interpretazioni, visioni del mondo, contrasti teologici e politici. È l’ebraismo di Maimonide e quello di Kafka, quello di Martin Buber e quello di Baruch Spinoza, quello dei profeti biblici e quello dei dissidenti laici. L’identificazione di questa tradizione ricchissima con un’entità politica moderna, peraltro nata solo nel 1948 in un contesto geopolitico ben preciso, è un’operazione di riduzione che tradisce l’anima stessa dell’identità ebraica.
Storicamente, l’esistenza di ebrei antisionisti è un fatto incontestabile. Non solo esistono da sempre correnti religiose, come quella dei Neturei Karta, che rifiutano il sionismo in quanto progetto politico profano e non messianico, ma l’ebraismo diasporico ha prodotto una vasta cultura critica nei confronti del nazionalismo ebraico. Grandi intellettuali come Hannah Arendt, Judith Butler, Ilan Pappé, Amira Hass e Gideon Levy (2) hanno espresso, da posizioni diverse, una critica profonda delle politiche israeliane, senza che ciò abbia mai intaccato la loro identità ebraica. Anzi, proprio la loro identità, nutrita da un senso acuto di giustizia, responsabilità e memoria, è stata spesso la fonte di tale dissenso.
L’abuso del concetto di antisemitismo da parte del governo israeliano non è solo un’operazione retorica interna: è anche un messaggio rivolto alla comunità internazionale. Serve a costruire una sorta di immunità morale per lo Stato d’Israele, il quale si presenta come depositario della sofferenza storica del popolo ebraico e pertanto come soggetto al di sopra del giudizio. Ma questa pretesa non regge alla prova della ragione. Come può uno Stato moderno, con uno degli eserciti più potenti del mondo, dotato di armamenti sofisticati, di appoggi internazionali cruciali e di un controllo capillare su un territorio occupato, rivendicare uno status di vittima perpetua? Come può, soprattutto, usare la memoria dell’Olocausto come scudo per giustificare operazioni militari che colpiscono civili, distruggono infrastrutture e minano le condizioni minime di sopravvivenza di un intero popolo?
In questo senso, il ricorso sistematico all’accusa di antisemitismo risulta doppiamente pericoloso. Da un lato, perché serve a delegittimare ogni forma di solidarietà verso i palestinesi, presentata come un’alleanza con il male. Dall’altro, perché svuota di significato il termine stesso di antisemitismo. Quando tutto è antisemitismo, nulla lo è veramente. Il risultato è che le vere manifestazioni di odio antiebraico — quelle che negano la Shoah, che propagano teorie del complotto, che vandalizzano sinagoghe, che attaccano individui per il solo fatto di essere ebrei — passano in secondo piano o vengono relativizzate, perdendo la giusta attenzione e la necessaria condanna.
Proprio per questo, l’abuso politico del trauma della Shoah appare ancora più insidioso. La Shoah è stata un abisso della civiltà, un crimine contro l’umanità che impone a tutte le coscienze una vigilanza costante. Ma il suo ricordo non deve essere trasformato in un capitale ideologico. Hannah Arendt, che fu tra le prime a denunciare questa strumentalizzazione, osservava con lucidità come Israele stesse utilizzando il ricordo dell’Olocausto non per elaborare un’etica universale del “mai più”, ma per costruire un’identità nazionale fondata sulla ferita e sul risentimento. Un’identità che, anziché aprirsi alla solidarietà con gli altri popoli oppressi, si chiudeva in una logica di autolegittimazione permanente. Il risultato è una narrazione vittimaria che, mentre rivendica il diritto alla sicurezza — diritto sacrosanto — si rifiuta di riconoscere i torti commessi, di vedere l’altro, il palestinese, come soggetto umano e portatore di dignità.
Qui la questione si fa propriamente filosofica. Perché ciò che è in gioco non è solo la geopolitica, ma l’idea stessa di giustizia. L’etica ebraica, nella sua più alta espressione, è un’etica della responsabilità verso l’altro, del rispetto del volto dell’altro, come insegna Emmanuel Levinas. Quando questa etica viene capovolta e il volto dell’altro — il volto palestinese — viene cancellato, ridotto a minaccia, a entità indistinta, a “problema demografico”, allora siamo di fronte non a un esercizio legittimo di autodifesa, ma a una forma pericolosa di tribalismo ideologico. Il vero pericolo non è la critica a Israele, ma la sua sacralizzazione: l’idea che Israele, in quanto Stato ebraico, sia al di sopra della legge, al di là del giudizio, immune alla storia.
Riconoscere tutto ciò non significa negare la legittimità dell’esistenza dello Stato di Israele. Significa affermare che ogni popolo ha diritto a vivere con dignità e a vedere riconosciuta la propria voce collettiva. Il valore etico delle scelte di un popolo — nella costruzione del proprio futuro, nella difesa della propria identità, nella rivendicazione della propria libertà — non si misura sulla base delle decisioni dei governi, ma sulla capacità di esercitare l’autodeterminazione senza violare i diritti fondamentali dell’altro. Opporsi alle violazioni dei diritti umani, da qualunque parte provengano; denunciare l’ingiustizia e la disinformazione; dare voce a chi è privato di dignità: tutto ciò non è un atto d’odio, ma un dovere morale per ogni essere umano. In questo senso, anche figure istituzionali di rilievo, come il ministro della Difesa del Regno Unito Luke Pollard, hanno sottolineato che il diritto all’autodifesa di Israele non giustifica violazioni del diritto internazionale umanitario. Inoltre, hanno ribadito che è del tutto irricevibile accusare di antisemitismo chi esprime una visione critica sulle modalità di autodifesa adottate da Israele (3). Tuttavia, se da una parte è inaccettabile giustificare con tali critiche chi propone la violenza come soluzione — come nel caso dell’Iran o di altri attori — dall’altra non si può nemmeno tacere di fronte a gravi violazioni dei diritti umani o all’eccesso nell’uso della forza, da qualunque parte provenga. Allo stesso modo, è inaccettabile ricorrere ad alibi che scarichino interamente su una sola parte la responsabilità del conflitto, eludendo la complessità storica e morale della situazione.
In conclusione, accusare di antisemitismo chi critica le politiche israeliane non solo è un errore logico e un’ingiustizia retorica, ma è anche un insulto al pensiero ebraico più profondo, che ha sempre saputo distinguere tra identità e ideologia, tra fede e potere, tra memoria e propaganda. La memoria della Shoah merita rispetto, non utilizzo politico. E la lotta contro l’antisemitismo merita serietà, non manipolazioni. Solo così sarà possibile onorare davvero le vittime del passato e costruire un futuro in cui giustizia e verità non siano più prese ostaggio da qualsiasi entità politica.