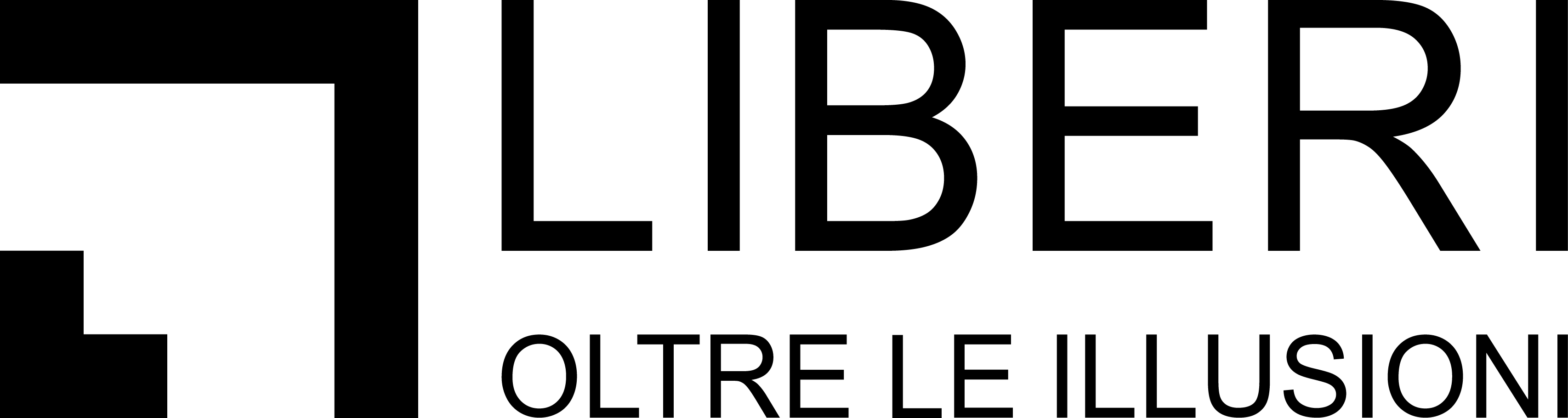La scomparsa di Enrico Berlinguer nel 1984 aveva lasciato il Partito comunista in grave crisi di identità. Il lungo percorso di avvicinamento al governo del Paese, percorso iniziato con le convergenze parallele con la DC e proseguito con il compromesso storico poi brutalmente interrotto anche dal rapimento e l’uccisione di Aldo Moro non si sarebbe ripresentato in uno scenario politico caratterizzato, per dirla alla Sartori, dal bipartitismo imperfetto, è altrettanto vero che l’assenza nella classe dirigente comunista di figure che potessero sostituire lo statista Sardo rappresentava un ostacolo insormontabile per formazioni di governo che avessero una presenza significativa della sinistra.
Craxi questo l’aveva capito e seppe incunearsi nel sistema conducendo una battaglia personale, e nei toni persino violenta, contro il PCI.
Il successore di Berlinguer, Alessandro Natta, in un mondo che cambiava velocemente, e il cui cambiamento avrebbe avuto una ulteriore sorprendente accelerazione, non seppe altro che riproporre timidamente un antico legame con il PCUS e l’Unione Sovietica che il predecessore, con coraggio e lungimiranza, aveva messo in discussione.
“Mi sento più sicuro stando di qua” aveva detto Berlinguer in un’intervista concessa al Corriere della Sera a proposito della NATO.
La segreteria Natta fu dunque di breve periodo e sostanzialmente effimera.
Nel 1988 gli successe Achille Occhetto che, conscio della crisi di identità del partito, abbandonò le pregiudiziali anticapitalistiche e promosse un profondo rinnovamento del gruppo dirigente.
Il 12 novembre 1989, anche sulla scia del crollo del sistema sovietico, Occhetto nella cosiddetta svolta della Bolognina tentò di recidere definitivamente il legame con Mosca e dare al partito una dimensione prettamente nazionale. Si ispirava a Gramsci e criticava Lenin senza mancare di prendere nettamente le distanze da Togliatti.
In altre parole Occhetto si era convinto che il PCI fosse destinato a morte certa e occorreva progettare e presentare una nuova sinistra.
Un taglio così netto con i nostalgici dell’Internazionale comunista, e dunque anche della contrapposizione con l’occidente e il capitalismo, non poteva che essere traumatico.
Il risultato fu che, lontani i tempi del centralismo democratico e della guida unitaria affidata ad un leader riconosciuto dal popolo comunista, all’interno del partito si andarono formando delle correnti: quella migliorista, sicura che lo scenario nazionale e internazionale non fosse più affrontabile con i dogmi della lotta di classe; e quella che potremmo definire nostalgico-massimalista, non pronta alla svolta e convinta che il partito avesse ancora il dovere, e lo spazio, per costruire l’alternativa alla socialdemocrazia.
Lo stato confusionale fu certificato dalla incapacità di scegliere un nome per il futuro partito che fu, fino al congresso del 1991, chiamato con l’enigmatico nome de La Cosa.
Uno dei tormenti di Occhetto e dei compagni, pur convinti della trasformazione del PCI, era anche quello di ammettere implicitamente una sconfitta programmatica rispetto agli attacchi portati dall’odiato Craxi.
Un altro era l’antico dettato di non avere nemici a sinistra, neanche ora che la scissione con i rifondatori comunisti appariva inevitabile.
Nel novembre del 1990 Occhetto ruppe gli indugi e presentò il nome del partito e il nuovo simbolo. Il PCI diventava, o per meglio dire moriva, per lasciare il posto al Partito Democratico della Sinistra (PDS); la falce e il martello lasciavano il posto ad una quercia.
La scissione, per opera di Armando Cossutta, Sergio Garavini, Ersilia Salvato e Lucio Libertini, avvenne e la falce e il martello furono messi nel simbolo del Partito Della Rifondazione Comunista, verso il quale confluirono anche Democrazia Proletaria e alcuni gruppi extraparlamentari.
L’iniziativa dei Cossuttiani, forse in teoria capace ancora di attrarre consenso verso la sinistra estrema, ebbe un arresto a seguito dei fatti di Mosca del 1991, quando lo scioglimento da parte di Gorbaciov del PCUS e il tentativo di colpo di Stato a Mosca rivelarono inequivocabilmente che la nostalgia per una storia politica ha poco senso se quegli stessi custodi della storia ne decretano la fine.
Il banco di prova elettorale per gli eredi del PCI arrivò con le elezioni del 1992. Il PDS prese il 16,1%; Rifondazione comunista il 5,6%. Alle elezioni precedenti il PCI aveva preso il 26,6%.
Ma, come abbiamo già visto, gli sconvolgimenti del sistema politico italiano non erano finiti; stava per abbattersi il ciclone tangentopoli e la discesa in campo di Berlusconi che portava nella lotta politica gli stilemi del bipolarismo.
Il PDS sopravvisse all’ondata di accuse di corruzione, anche se era ben evidente che non era stato immune dai fenomeni tangentizi e dal sistema di potere che aveva caratterizzato tutta la prima repubblica.
Occhetto e D’Alema furono sfiorati dalla vicenda Enimont e Primo Greganti, cassiere del PCI-PDS torinese fu accusato di aver trasferito oltre 600 milioni di lire in un conto cifrato in svizzera quale frutto di tangenti. L’ostinato silenzio del Compagno G, sottoposto a 6 mesi di custodia cautelare in carcere in attesa di qualche rivelazione, e infine condannato in via definitiva a 3 anni gli valsero l’appellativo di eroe da parte dei militanti comunisti.
Alle elezioni del 1994 si presentano partiti nuovi e senza radicamento sul territorio. Gli unici avere un qualche radicamento, frutto dell’eredità comunista, sono il PDS di Occhetto e Rifondazione Comunista di Cossutta.
Spetta al primo però proporre un rassemblemant della sinistra italiana da contrapporre a Berlusconi
I Progressisti, la gioiosa macchina da guerra per dirla alla Occhetto, si fermarono al 32,8% anche per la decisione dei referendari di Segni di correre da soli nelle prime elezioni con una forte componente elettorale maggioritaria. Le coalizioni di destra, Polo delle Libertà e Polo del buon governo arrivarono al 47,3%
Per la parte proporzionale il PDS ottenne il 20,4% e Rifondazione Comunista il 6%.
La sconfitta alle politiche, inattesa per sottovalutazione dell’avversario, diventò sgomento pochi mesi dopo quando alle europee il partito di Berlusconi, che a marzo era avanti di solo un punto, volò oltre il 30%.
La doppia sconfitta portò Occhetto, colui che aveva tentato di trasformare il PCI, alle dimissioni.
Per la successione si confrontarono ancora una volta due anime: la prima rappresentata da Massimo D’Alema, già dirigente della FGCI, a favore di una continuità con il percorso intrapreso e poco incline ad una rottura netta con il passato; la seconda rappresentata da Valter Veltroni, orientato ad una rottura netta e affascinato dalle esperienze progressiste anglosassoni e dal cosiddetto kennedysmo (poi diventato clintonismo e poi ancora blairismo).
A prevalere fu D’Alema.
Da un punto di vista tattico, la strategia dalemiana di riportare il Paese alla normalità contro l’anomalia Berlusconiana, risultò vincente. Il buon risultato alle amministrative consentì a D’Alema di presentarsi al congresso come vincitore e come unico capace di arginare l’onda forzista.
Ma, abbiamo detto, la politica italiana era ormai avviata sulla strada del bipolarismo e gli slogan provenienti da destra evocavano una conventio ad escludendum verso gli eredi del comunismo.
In soccorso venne chiamato un vecchio dirigente pubblico di area cattolica, economista e già presidente dell’IRI. Romano Prodi.
Prodi rappresentava una valida alternativa all’efficientismo di Berlusconi e portava con sé parte del voto cattolico.
La nuova coalizione per il voto del 1996 aveva ora come simbolo l’Ulivo ed è composta dai partiti di sinistra (PDS e Verdi) e da partiti di centro (Popolari e Rinnovamento Italiano di Lamberto Dini)
Il complesso meccanismo elettorale non diede la maggioranza dei voti alla coalizione di Prodi che però ottenne un comodo vantaggio alla Camera mentre dovette ricorrere all’appoggio di Rifondazione comunista al Senato.
Ottenuto il governo, D’alema si concentro sull’allargamento ai reduci socialisti senza però dare una ulteriore svolta alla trasformazione del partito se non per un nuovo cambio di nome che diventò DS, Democratici di sinistra.
A prescindere dal resto e dagli esiti delle successive elezioni, che videro l’Ulivo perdere quelle del 2001 e sostanzialmente pareggiare quelle del 2006, la via delle coalizioni era definitamente tracciata e i DS furono il perno della sinistra; almeno fino all’arrivo di un nuovo fenomeno: il populismo.