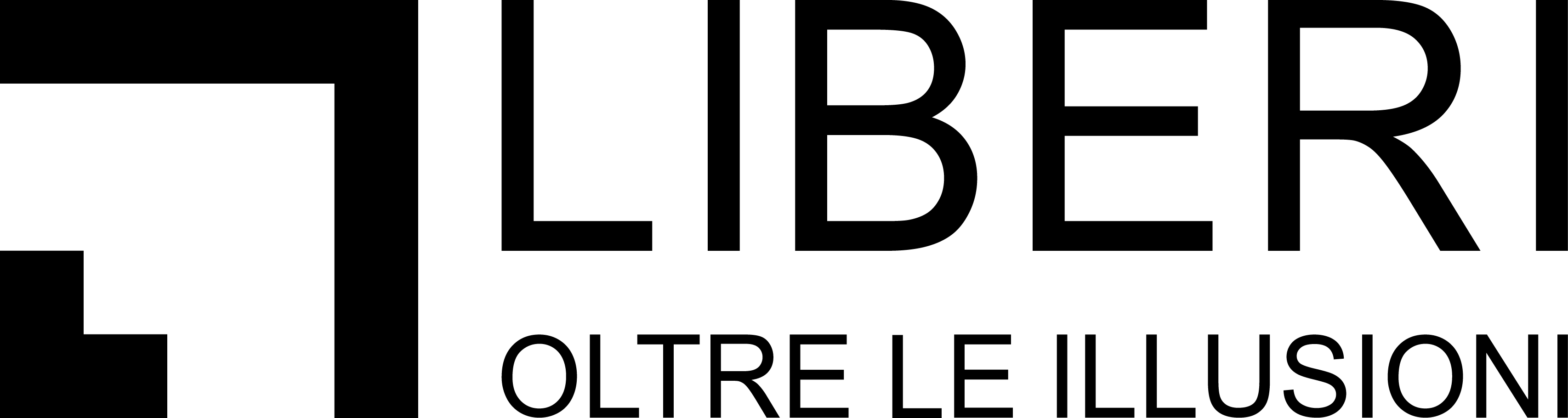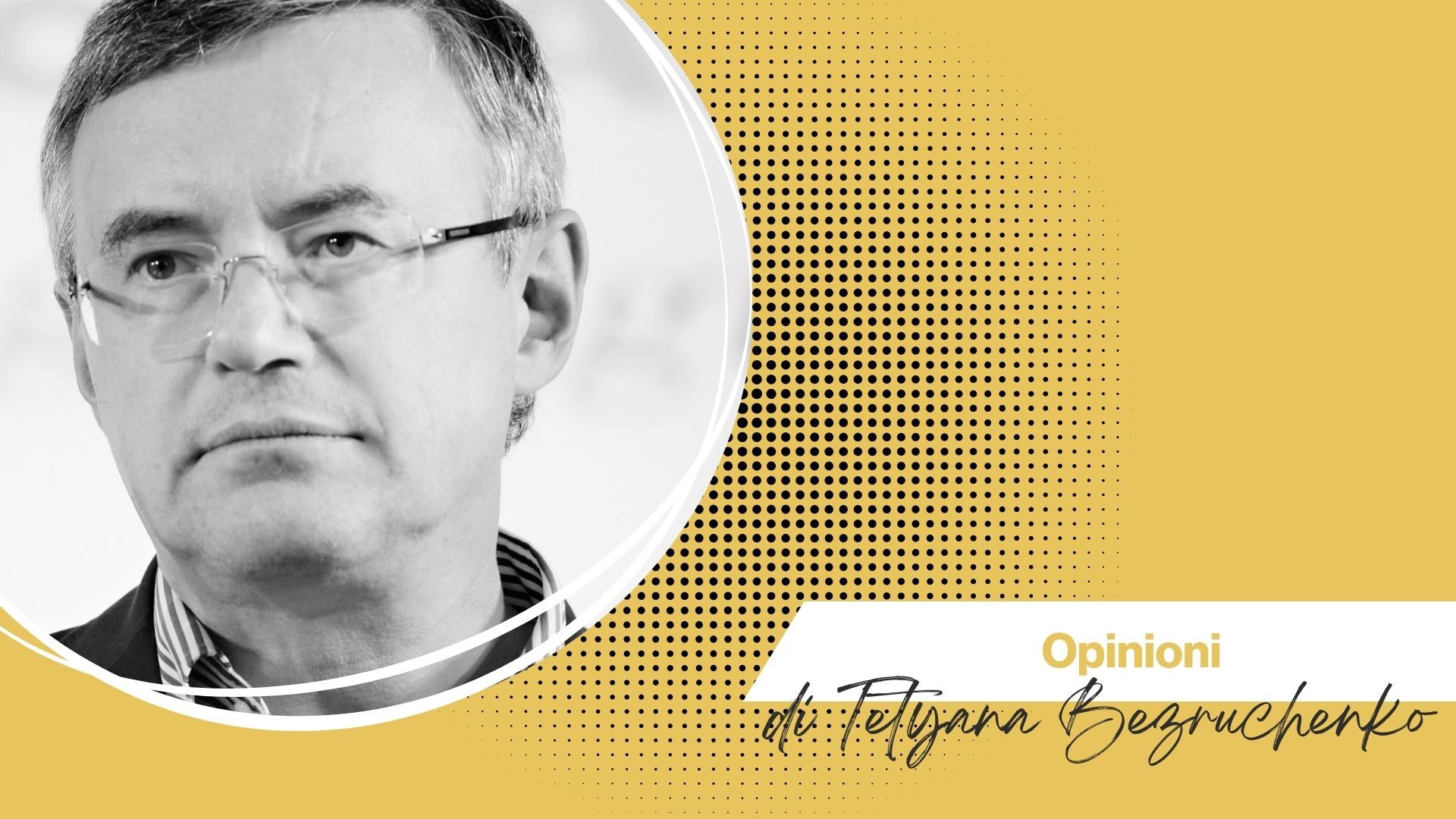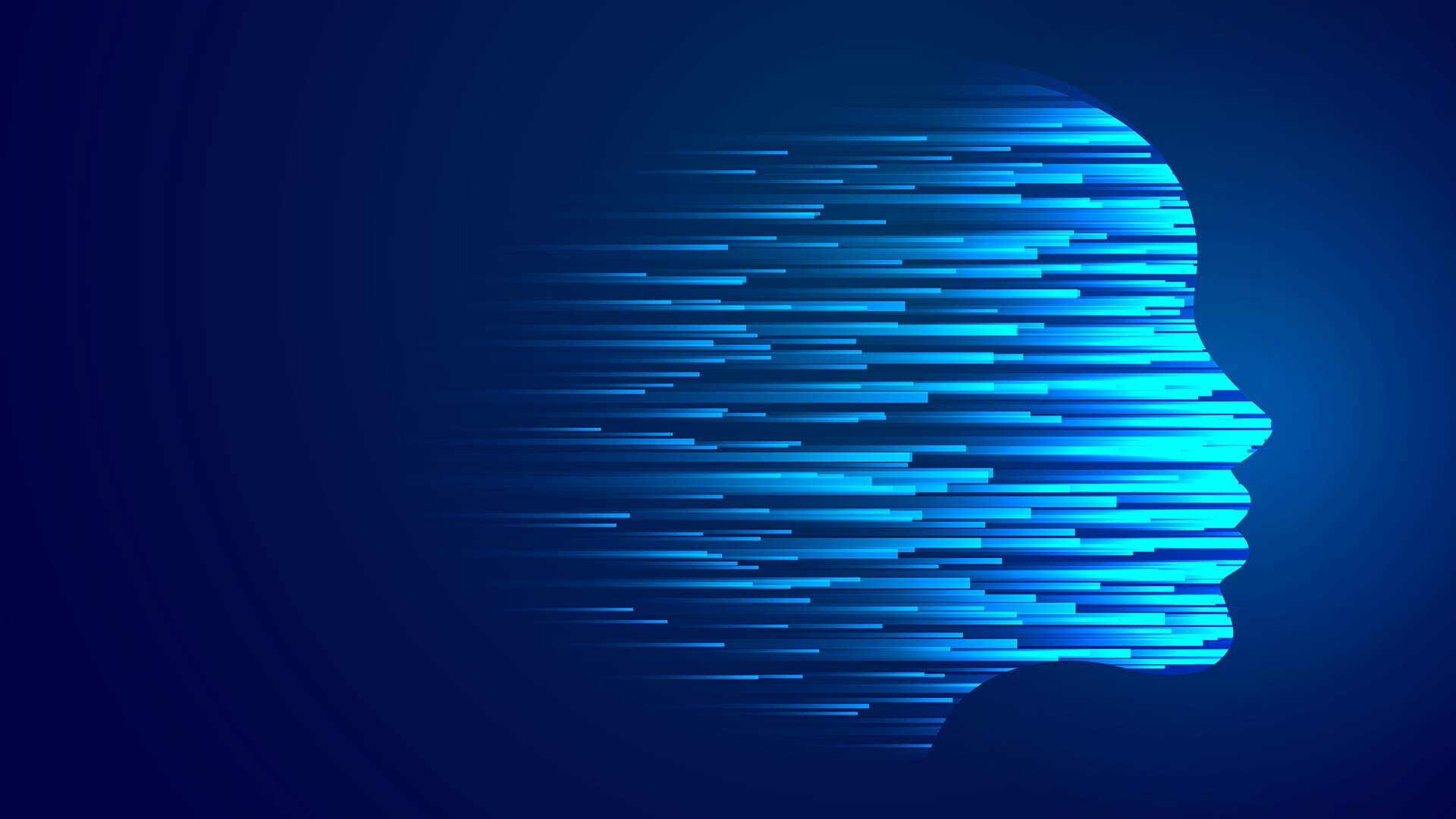Da quando lo scorso 30 luglio Unicredit ha annunciato l’approvazione dei presupposti per un’operazione d’acquisto delle attività commerciali di Monte dei Paschi di Siena, è tornata alla ribalta la vicenda dell’istituto senese che ha sollevato urla sireniche di una politica che all’unisono ha espresso sostanzialmente lo stesso concetto: svendita.
Ma è davvero così? Si può parlare di svendita per Monte dei Paschi? Assolutamente no.
La terminologia è importante: si ha una svendita solo se si vende per un valore inferiore a quello reale e il caso in esame – come è emerso nella chiacchierata di qualche giorno fa tra Mario Seminerio e Costantino de Blasi – è di una tale criticità che si potrebbe rinominare la banca in Monte Popolare delle Sofferenze, ovvero Populista delle Sofferenze.
Guardiamo in faccia la realtà.
La banca arriva da un 2020 in perdita, con ricavi in discesa che si sommano al peso dell’attività di derisking del proprio portafoglio crediti: negli ultimi anni sono stati diversi i miliardi di sofferenze e inadempienze probabili ceduti (con l’intervento ultimo di AMCO, società statale nata come bad bank del Banco di Napoli nel 1997), ma le prospettive – vista la situazione Covid – rimangono tutt’altro che rosee in termini di qualità creditizia.
A ciò si aggiungono poi gli esisti degli ultimi stress test: in caso di scenario avverso – quest’anno concretizzato in un prolungamento dell’impatto del Covid con un periodo di tassi d’interesse bassi per più tempo – la banca rischierebbe di finire con il c.d. CET1 addirittura negativo da qui al 2023, un rischio non nuovo ai vertici dell’Istituto tanto da aver già previsto nel c.d. “capital plan” un aumento di capitale da 2,5 mld.
Quanto sopra in realtà, non sorprende più di tanto, vista che la stessa partecipazione detenuta oggi dal MEF (al 31/12/2020 pari al 64,23%) è figlia di quella ricapitalizzazione precauzionale da 5,4 mld operata nel 2017 in conseguenza all’incapacità di MPS di rafforzare il patrimonio tramite il privato, a seguito degli esiti degli stress test del 2016. Un passaggio questo fondamentale dell’intera vicenda MPS visto che tale intervento venne autorizzato dalla Commissione Europea con dei paletti ben precisi, tra cui la cessione di tale partecipazione entro un termine preciso (termine ultimo aprile 2022 con l’approvazione dei conti 2021).
Per inciso, la cessione non è mai stata una novità dell’ultima ora, visto che nel corso degli anni si sono sentite le proposte più disparate per risolvere la situazione, uscite che per certi versi fanno sorridere visto che è la stessa politica ad essere stata fonte di crisi per MPS.
Sta di fatto che ad oggi solo Unicredit – dopo una resistenza non irrilevante – si è fatta avanti per acquisire MPS, con una proposta che però sarà tutt’altro che a costo zero per i contribuenti e che assomiglia sempre più al caso delle popolari venete acquisite da Intesa, fermo restando che qui non è mai stato dichiarato lo stato d’insolvenza vista la mancanza di presupposti.
Mustier – ex CEO di Unicredit – si era opposto più volte all’acquisto dell’istituto, il che è del tutto comprensibile: tali operazioni di salvataggio non sono una novità per il nostro sistema bancario, ma presentano sempre il rischio che la malattia del “comprato” sia tale che il compratore non sia così forte da non rimanerne infetto, facendo degenerare ulteriormente la situazione.
In tal senso, col nuovo piano industriale lui puntava non tanto sulle acquisizioni (di cui Unicredit in passato è stata protagonista), quanto su crescita organica, distribuzione di dividendi e riacquisto di azioni proprie, rinunciandovi poi ufficialmente perché il C.d.A. non avrebbe dato la sua fiducia a tale proposta.
Con la nuova guida Padoan-Orcel si punta invece ad acquisire MPS, ma le condizioni poste puntano ad avere un’operazione a costo zero per Unicredit che si tradurrebbe in:
- neutralità in termini di capitale;
- accrescimento significativo dell’utile per azione;
- la protezione dai contenziosi legali di natura straordinaria;
- esclusione dei crediti deteriorati da qualsiasi transazione.
con il resto a carico ai precedenti azionisti (ergo ai contribuenti). Un peso – stimato dal Sole 24 ore – che, includendo l’intervento del 2017, salirebbe fino a 10 mld tra crediti d’imposta, aumenti di capitale a carico del MEF già previsti ancor prima (1,5 mld), cause legali e sofferenze ed esuberi (con probabile intervento per quest’ultimi del fondo di solidarietà bancario).
Dunque un’uscita tutt’altro che gratuita ma unica sul tavolo e questo, ci porta a una domanda già sopra emersa tra le righe: se la situazione di MPS è così critica anche dopo tutti gli interventi dell’ultimo decennio – dai Tremonti e Monti bond, alle ricapitalizzazioni private fino all’intervento d’emergenza del 2017 – perché si continua a parlare di svendita?
La verità è a dir poco semplice quanto palese, come emerso dalla chiacchierata: banca significa denaro e denaro, per un politico, significa la possibilità di fare quelle azioni con cui preservare il consenso.
MPS – invero – è l’ennesima dimostrazione di come la politica sia pestilenziale quando contamina la logica della sana e prudente gestione con i suoi interessi, una verità che tutti noi abbiamo di fatto conosciuto a livello globale con la crisi del 2008, viste le sue origini nella politica dei prestiti politicamente corretti e di una FED espansiva quando non doveva esserlo.
È la storia stessa della banca ad evidenziarlo, una serie di vicende al limite del ridicolo se non fosse per la loro gravità: la fondazione – nata durante la privatizzazione del sistema bancario negli anni ’90, praticamente di nomina politica (metà dell’organo direttivo è nominata da comune, provincia e regione) e azionista di maggioranza dell’istituto fino a qualche anno fa – tollerò le operazioni più rischiose come l’acquisto di Antonveneta e i derivati, le quali hanno preponderanteménte contribuito all’attuale crisi dell’istituto senese.
Invero si pensi poi all’ultima vicenda legale tra fondazione e MPS: la richiesta di risarcimento della prima di 3,8 mld avanzata verso la seconda per i danni patrimoniali derivanti dall’acquisizione di Antonveneta e per aumenti di capitale 2011, 2014 e 2015, si risolve in un accordo di 150 mln e impegni sulla valorizzazione del patrimonio artistico della banca. In sostanza? Meno del 4% preteso e qualche opera d’arte per eventi.
Cosa possiamo quindi concludere?
Che a prescindere da tutto ciò – un tassello imprescindibile della nostra storia economica che dovrà essere insegnato e conosciuto da tutti coloro che studiato economia in particolar modo – è ora di porre una fine alle perdite (il c.d. stop loss): troppo alto il costo che l’intera collettività ha dovuto sopportare per negligenza e ritardi dovuti all’avidità e all’incompetenza di pochi.
Nessuno nega che tale operazione avrà un impatto non irrilevante sulla città di Siena e relativa provincia – viste comunque le necessarie trattative in materia di esuberi (una costante in realtà di qualunque operazione di fusione societaria) – ma deve terminare l’idea che gli istituti bancari siano realtà da salvare a tutti i costi: sono imprese e come tutte le imprese possono avere una fine.
E questo vale anche per la c.d. banca più antica del mondo: l’eternità non è di nessuno.